L’Esploratore/Esploratrice Pop
Questo Prolegomeno illustra il profilo dell’Esploratore/Esploratrice Pop, che si aggiunge ai primi cinque della serie Che Pop Manager sei?: Esteta , Visionario/Visionaria, Innovatore/Innovatrice, Empatica/Empatico, Simposiarca.
 Come icona maschile del quiz Che Pop Manager sei? Esploratore/Esploratrice ho scelto un Harrison Ford ibrido, un po’ Indiana Jones, un po’ Rick Deckard (il Blade Runner) (per ulteriori approfondimenti rimando a uno dei classici di Hamlet, l’Editoriale del numero 16 (Blade Runner o Folletto?). Queste le motivazioni.
Come icona maschile del quiz Che Pop Manager sei? Esploratore/Esploratrice ho scelto un Harrison Ford ibrido, un po’ Indiana Jones, un po’ Rick Deckard (il Blade Runner) (per ulteriori approfondimenti rimando a uno dei classici di Hamlet, l’Editoriale del numero 16 (Blade Runner o Folletto?). Queste le motivazioni.
- Simbolica dell’Esplorazione. Indiana Jones simboleggia l’esplorazione del passato, della memoria e del mito, avventurandosi in territori ignoti. Rick Deckard, invece, esplora l’umano in un futuro distopico, tra androidi e identità artificiali, interrogandosi sull’ambiguità ontologica. L’Esploratore Pop si posiziona tra questi due archetipi, indagando il passato per reinterpretarlo nel presente e proiettandosi nel futuro per anticiparne i segnali, fungendo da ponte tra archeologia e futurologia, analogico e digitale.
- Filosofia dell’Ibrido. Indiana Jones è un professore e un avventuriero: un intellettuale che agisce, un accademico che si sporca le mani. Rick Deckard è un cacciatore di replicanti che dubita della propria umanità: un uomo che si interroga sul confine tra naturale e artificiale, tra realtà e simulazione. L’Esploratore Pop è un ibrido per vocazione: un manager-filosofo, un creativo-sistemico, un hacker culturale che si muove tra i codici della cultura pop e le mappe del pensiero critico.
- Narrazione e Metanarrazione. Entrambi i personaggi sono eroi riluttanti: non cercano la gloria, ma si trovano coinvolti in trame più grandi di loro. Sono narratori immersi nella narrazione, spesso in bilico tra il ruolo di protagonista e quello di testimone. Indiana Jones combatte per salvare oggetti simbolici (l’Arca, il Graal), Deckard per salvare (forse) l’idea stessa di umanità. L’Esploratore Pop è un narratore metaconsapevole: sa che ogni organizzazione è una storia, ogni progetto un racconto, ogni innovazione una riscrittura del reale. E agisce come autore e lettore del proprio percorso.
- Estetica e Iconografia. Il cappello di Indiana e l’impermeabile di Deckard sono segni riconoscibili, simboli di due estetiche opposte ma complementari: l’archeologia pulp e il noir cyberpunk. L’immagine li fonde in un’unica figura, con giungla e città futuristica sullo sfondo: un perfetto paesaggio mentale dell’Esploratore Pop. L’Esploratore Pop è un’icona in movimento, che attraversa ambienti, linguaggi e immaginari. È un avatar narrativo che può abitare tanto un tempio perduto quanto un metaverso.
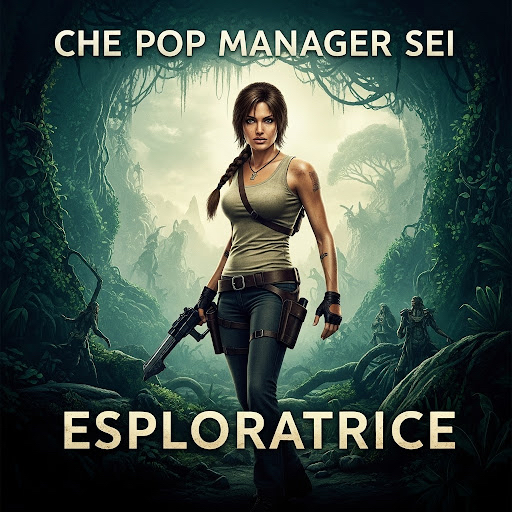
Lara Croft è stata la mia scelta come icona Pop dell’Esploratrice perché è:
- Una scopritrice di confini, non solo geografici. Lara Croft esplora non solo luoghi fisici come tombe e rovine, ma anche confini culturali, simbolici e interiori. È una figura che dissotterra verità dal passato, affronta l’ignoto con coraggio e trasforma ogni spedizione in un viaggio significativo. Il suo obiettivo non è solo la scoperta di tesori, ma la creazione di connessioni tra mondi diversi;
- Autonomia e leadership incarnata. Lara Croft incarna autonomia e leadership, essendo indipendente, resiliente e autodeterminata. Le sue azioni sono frutto di scelte e rischi personali, facendola un modello di leadership trasformativa che guida con l’esempio. Contribuisce all’empowerment narrativo, riscrivendo il ruolo femminile nell’avventura, e promuove un’etica dell’azione dove ogni scelta e gesto costruisce identità;
- Figura liminare e ibrida. Lara Croft esiste tra realtà e finzione, videogioco e cinema, azione e riflessione. È allo stesso tempo fisica e digitale, umana e mitica, un avatar culturale che attraversa generi, media e immaginari. Incarna l’ibrido, il frammento e il remix.
- Curatrice di esperienze immersive. Ogni avventura di Lara Croft è un’esperienza immersiva e un viaggio simbolico, dove ogni rovina è un testo da decifrare e ogni ostacolo una prova iniziatica. Le sue scoperte sono atti di conoscenza incarnata. Come l’Esploratore Pop, non si limita a collezionare oggetti, ma costruisce narrazioni.
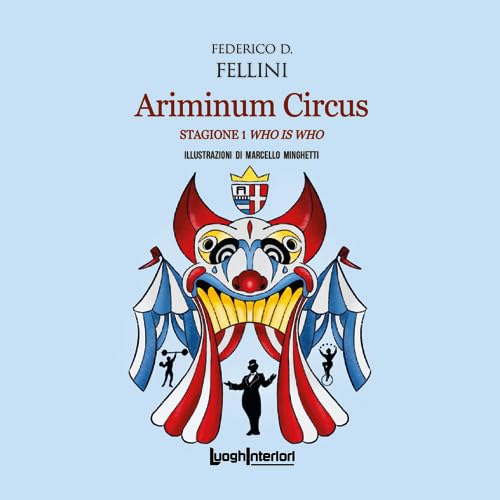
Ariminum Circus
Questa volta ho costruito le domande tenendo presente Ariminum Circus inteso come progetto transmediale che si articola su più dimensioni: raccolta di immagini per Pinterest, Wikiromance in Instagrammi, libro illustrato, videogioco, graphic novel, versione per Wattpad.
Una piattaforma narrativa complessa particolarmente coerente con la forma e i contenuti dei quiz Che Pop Manager sei? a partire dal Test d’ammissione iniziale, che chiede al lettore di valutare la propria affinità con l’opera attraverso dieci affermazioni. Proprio come i nostri Pop Quiz che si articolano in 10 domande e rimandano ad altrettanti snodi concettuali riferiti ai principi del Pop Management.
Il “Test d’ammissione” è un dispositivo metanarrativo che funge da dichiarazione di poetica, non solo da gioco. Similmente al romanzo, il test è un ibrido di filosofia pop, cultura digitale, letteratura sperimentale e ironia postmoderna. È un atto performativo che crea un “Lettore Ideale”, un personaggio a tutti gli effetti dell’universo narrativo. Che deve condividere una visione del mondo caratterizzata da contaminazione di generi e linguaggi, rifiuto della linearità narrativa, apprezzamento per il “weird”, l'”eerie”, il “mash-up”, l’accettazione dell’ambiguità e della molteplicità dei punti di vista.
Ogni affermazione del test è una domanda travestita da specchio: non chiede solo “ti piace questo?”, ma “sei disposto a mettere in discussione il tuo modo di leggere, pensare, vivere?”. È un invito a decostruire l’identità del lettore e a ricostruirla dentro un ecosistema narrativo che è anche un laboratorio filosofico.
Il test e l’intero progetto spaziano tra alta cultura e cultura pop, unendo riferimenti da Joyce ai manga, da Heidegger ai videogiochi. Questo crea un “glitch estetico”, dove un’apparente “captatio benevolentiae” si trasforma in un “incitamentum malevolentiae”, rivelando nuove forme di significato. Ciò è coerente con la descrizione di “Ariminum Circus” come “romanzo lisergico e filosofico” che “deflagra la contemporaneità”, secondo la Giuria del Premio Calvino.
Infine, il Test d’ammissione non è solo un filtro, ma un rito di passaggio. Chi totalizza un punteggio alto non è solo “adatto” al libro: è iniziato a un nuovo modo di intendere la letteratura, la realtà e l’identità. È un lettore che diventa personaggio, e viceversa.

Rimini / Ariminum
«Rimini è un oggetto sentimentale», scrive Silvia Bottani in Paesi e città. Rimini (Doppiozero, Luglio 2025) e questa definizione sembra echeggiare la controcopertina di Ariminum Circus – Stagione 1, dove la città viene presentata come «una Rimini stroboscopica alla vigilia dell’Armageddon». Entrambe le visioni – quella saggistica e quella narrativa – convergono nel rappresentare una città-limite, cerniera tra reale e immaginario.
Nel testo di Bottani – in cui l’autrice vagabonda per le strade cittadine seguendo un itinerario molto simile a quello percorso dal Roc nella vertigine onirica descritta nelle prime pagine del romanzo e come successivamente faranno il Piccolo Ed e il Maestro con il supporto della app Ubik Roi – il Grand Hotel è il simbolo felliniano per eccellenza, luogo di sogni e malinconie. Rielaborando una celebre descrizione fatta da Fellini stesso, vi introduco uno dei protagonisti del romanzo (e del videogioco): «Jay s’immerse in un ambiente che nemmeno gli effetti speciali di Avatar potrebbero eguagliare. I muri più immacolati dei ponti di una nave da crociera; i mobili francesi stile Impero color tabacco, eleganti come le banchine in palissandro dello Yacht Club; le cache-pots con pesci di Galileo Chini; i divani beige, barche immobili fra i gli atolli dei Flower Tables nella calma piatta dell’immensa hall, su cui calavano le migliaia di boe sferiche in cristallo di Burano del monumentale velario; la guida fiammeggiante che saliva curvando di bolina stretta sulla gradinata di marmo verso i fari sfolgoranti delle vetrate policrome; le finestre circolari, disegnate da Henry Holiday, oblò Art Nouveau che aprivano scorci di Cielo fra gli alberi sempreverdi del parco…» – Episodio 3 (Amarcord) Jay e Daisy. Alla fine del capitolo Jay e Daisy balleranno sulla scalinata del grande albergo, ripercorrendo i passi della celebre danza di Amarcord.
Il lungomare evocato in Paesi e città. Rimini come spazio di passeggio e flânerie («nel tempo, ho appreso che la Rimini turistica non coincide con quella vissuta da un residente, se non in piccola parte. Un’evidenza chiara soprattutto in estate, quando la parte della Marina si affolla fino all’inverosimile, lasciando respirare il resto della città. Una evidenza che spesso sfugge a chi non vive qui e che immagina Rimini essenzialmente come un lungomare caotico e iper turistico») si trasforma nel romanzo in Spiaggia Iperurania, covo degli Artisti Dannati e dei Precog: «accessibile solo a chi conosce la Via, impraticabile e necessaria, dell’andare-oltre», mentre il porto canale leonardesco, che nel post di Doppiozero è luogo di sosta («il porto canale che conduce al faro… sedersi sulla panchina ai suoi piedi, osservando le barche in rimessa sugli argani del cantiere è un impagabile modo di perdere tempo»), in Ariminum Circus diventa palco per la partenza dell’Asso di Cuori.
Conversando con Marisa Parmeggiani in occasione dell’uscita del suo saggio su Rimini, le dicevo: «Il primo capitolo del tuo libro s’intitola “La Palata”, che in dialetto indica l’ultimo tratto del Molo di Levante. Un luogo simbolo della città “rinata dalle macerie come un gigantesco set di cartapesta su cui proiettare sogni e desideri”. E così, “ecco quel pazzo di Scurèza ad Corpolò sfrecciare in moto. Ecco il profilo del transatlantico Rex, che non importa se costeggiò la Riviera Romagnola solo una volta, e a luci spente, durante la Seconda guerra mondiale. Nel punto esatto dove la terra finisce e le onde s’infrangono contro gli scogli, là dove i vitelloni sognano avventure e fughe d’amore, inizia la Rimini di Fellini, la città immaginaria, provinciale e bigotta ma anche vitale e godereccia, la dimensione di una memoria dichiaratamente inventata, adulterata, manomessa”.
Anche io, nel capitolo di Ariminum Circus che apre la narrazione vera e propria (Episodio 2, Il Roc), descrivo una sera ad Ariminum attraverso “i passi della gente (che) strusciavano verso il porto per assistere alla partenza dell’Asso di Cuori, il mitico transatlantico dalle linee eleganti, dinamiche, positive di un Vorticismo slanciato verso un orizzonte di sorti magnifiche e progressive, benché probabilmente illusorie. Era diretto verso la fine del mondo, alle dimore ultraterrene del jet set internazionale – affascinante e irraggiungibile – che aveva trascorso un periodo di villeggiatura nelle quarantadue stanze esclusive del Grand Hotel, arredate con autentici pezzi veneziani del diciottesimo secolo, al riparo della facciata liberty rosa fenicottero”, concludendola con la mia reinterpretazione di Scurèza: “Calata ormai la notte, il molo – la Palata – si svuotava, lasciando spazio a Crepitu, il motociclista che correva su e giù rombando e peteggiando”».
Il Corso d’Augusto e il Mercato Coperto «dove comprare – scrive Boitani – dai banchi dei pescatori sardoncini, pescetti di paranza e “poveracce”, le vongole che un tempo accompagnavano la polenta e, oggi, i più ricchi passatelli» diventano nel romanzo «i genitali del colosso» attraversati dal Roc fino alla Zona 414 (Barafonda), dove si mescolano bordelli, varietà e memorie del Rubicone. È un remix urbano che fonde Fellini, cyberpunk e mitologia romagnola.
Vi è poi il Fulgor, che nella conversazione con Parmeggiani rievochiamo così: «M.M.: Un altro luogo mitico della Rimini felliniana è il cinema Fulgor, cui doverosamente tu dedichi un capitolo. Nella mia Ariminum diventa “l’Ospedale Psichiatrico Fulgor: buen retiro di derelitti, subnormali, mongoloidi dalla testa grossa, deformi, con la bocca aperta, bavosa e la cui nettezza era visibilmente compromessa da residui di cibo e succhi gastrici. Costretti in camicie Posey e legati a poltroncine con pinze per tenere spalancate le palpebre, stavano ammassati in un dormitorio ribollente di voci, sudori, popcorn, gazzose e stringhe di liquirizia a fare da cannucce; con le infermiere, i brodini caldi, la pipì degli incontinenti”, in una fusione tutta personale con l’Arancia Meccanica di Kubrick. Per te invece cosa rappresenta?
S.P: Un buen ritiro sicuramente, ma dalle angosce e dai dolori terreni. Il Fulgor ai tempi di Fellini non era un cinema, ma il Cinema, vale a dire la calda cloaca di ogni vizio. Sulle sue pancacce di legno il grande regista ebbe il primo incontro con la macchina dei sogni e anche con un certo tipo di femminilità. Il primo film che vide, infatti, seduto sulle ginocchia del padre, era un tormentone storico – Maciste all’Inferno – con in scena Elena Sangro, diva del cinema muto, rappresentata semi nuda, con gli occhi bistrati, le forme generose fino all’indecenza. E quel cinema, oggi rinato grazie agli allestimenti del premio Oscar Dante Ferretti, mantiene intatto il suo fascino: niente pancacce di legno o sale fumose, ma stucchi dorati e porpore rosse, un tripudio di decorazioni in stile romagnol-hollywodiano che è uno stile che non esiste ma che ci riporta all’epoca d’oro del cinema, quando entrare in una sala buia significa lasciare fuori le preoccupazioni e immergersi in un sogno”».
Quindi il liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini, dove Federico Fellini studiò dal 1930 al 1938. Questo liceo, anche se non esplicitamente nominato in Amarcord, è chiaramente riconoscibile nelle scene che rappresentano l’ambiente scolastico e l’esperienza di Fellini durante la sua adolescenza, diventando un simbolo di quel periodo e di quella specifica esperienza formativa, rivisitata attraverso la lente onirica e malinconica del grande regista. L’Asilo Kandinskij, con i suoi Bimbi Perduti, è la controparte distopica della scuola evocata dalla cinematografia felliniana, in particolare in Amarcord: un luogo dove l’infanzia non è più promessa, ma già esperienza traumatica. I “Bimbi Perduti” non sono scolari, ma figure liminari, quasi spettri dell’identità in formazione. Il nome stesso dell’asilo richiama Kandinskij, pittore dell’astrazione e della sinestesia, suggerendo un ambiente sensoriale e disorientante, lontano dalla concretezza pedagogica tradizionale. L’infanzia, in Ariminum Circus, è già passata, già ferita, già narrata. Non è più uno spazio di crescita, ma un archivio di esperienze interrotte. Questo rovescia la visione felliniana, dove l’infanzia è fonte di stupore e meraviglia. Qui, invece, è simulacro di ciò che è stato, eco di un’educazione mancata.
Infine, la statua di Giulio Cesare che nel saggio di Bottani segna il cuore della città, nel romanzo è trasfigurata in un Mazapégul elefantiaco seduto su un vespasiano-piramide, tra hotel-matrioska e chiese a forma di violino. È la Rimini che non si limita a essere vissuta, ma che va decifrata come un manga filosofico.
In questo paesaggio ibrido, l’Esploratore Pop si muove come lettore aumentato e narratore sistemico, capace di cogliere nei luoghi della città – reali o immaginari – le tracce di un futuro già accaduto. Rimini/Ariminum non è solo uno sfondo: è un personaggio, un dispositivo cognitivo, una mappa mentale che chiede di essere attraversata con occhi nuovi.

L’Unità Molteplice
Il remoto re degli uccelli, il Simurg, – racconta Borges nel suo Manuale di zoologia fantastica – lascia cadere in mezzo alla Cina una piuma splendida; gli uccelli risolvono di cercarlo, stanchi della loro antica anarchia. Sanno che il nome del loro re significa trenta uccelli; sanno che la sua reggia è nel Kaf, la montagna o cordigliera circolare che cinge la terra. Al principio, per paura, alcuni si scherniscono: l’usignolo allega il suo amore per la rosa; il parrocchetto la sua bellezza, che gli è ragione di vita ingabbiata; la pernice non può prescindere dalle colline, nè la gazza dalle paludi, nè il gufo dai ruderi. Alla fine, si lanciano nella disperata avventura; superano sette valli, o mari; il ponte del penultimo è Vertigine; l’ultimo si chiama Annichilimento. Molti pellegrini disertano; altri periscono nella traversata. Trenta, purificati dalle proprie fatiche, toccano la montagna del Simurg. Lo contemplano finalmente; s’accorgono che essi stessi sono il Simurg e che il Simurg è ciascuno di loro.
Così, nel saggio Il Simurgh e l’Aquila, contenuto in Altre inquisizioni (Otras inquisiciones, 1952), Borges riassume e interpreta il poema sufi Mantiq al-Tayr (Il Verbo degli uccelli) di Farid al-Din Attar, dove il Simurg è simbolo della conoscenza divina e dell’unità spirituale.
Ma, come sottolineavo già in un Editoriale di Hamlet nel lontano 1997, quello borgesiano è un apologo di formazione che si presta perfettamente a incarnare un modello di leadership collaborativa che nel Manifesto dello Humanistic Management chiamavamo Unità Molteplice, volendo sottolineare l’importanza della capacità manageriale di tenere insieme differenze, contraddizioni e prospettive eterogenee senza ridurle a una sintesi piatta, ma valorizzandole nella loro tensione creativa. Il Simurg, in questo senso, è uno e molti: un simbolo che unifica senza omologare, che vola alto ma porta con sé la molteplicità dei mondi che attraversa.
Nel Manuale di zoologia fantastica, lo scrittore argentino descrive poi il Roc: un uccello mitologico di proporzioni titaniche, capace di sollevare elefanti e oscurare il cielo. Ora, la graphic novel tratta da Ariminum Circus ne riprende il Secondo Episodio, Il Roc, dove i due uccelli mitici si fondono: simbolo del Pop Manager che è Simurg e Roc insieme.
Potente e collettivo, visionario e relazionale, è colui che non teme la sproporzione, ma la abita. È un narratore sistemico, un curatore di immaginari collettivi, un facilitatore di intelligenza collaborativa. La sua leadership non è verticale, ma convocativa; non è fondata sul controllo, ma sulla capacità di generare spazi di senso condivisi. È un manager che non cerca l’unità nella semplificazione, ma nella coerenza dinamica tra le differenze.
In sintesi, il Roc diventa metafora della formazione continua, dell’identità in divenire, della leadership che si costruisce nel dialogo tra l’uno e i molti. È il simbolo di un umanesimo popmanageriale che non rinuncia alla profondità, ma la reinventa come pratica relazionale, narrativa e trasformativa.

L’ergonomia cognitiva
L’ergonomia cognitiva intesa come disciplina che studia l’interazione tra mente umana e sistemi complessi (fisici, digitali, simbolici), di cui abbiamo più volte parlato nei nostri Prolegomeni, è in linea con la filosofia e la pratica narrativa di Ariminum Circus.
Qui ogni personaggio, luogo e situazione è un dispositivo cognitivo: un’interfaccia narrativa che stimola il pensiero laterale, la riflessione critica, l’immaginazione. L’ergonomia cognitiva, in questo contesto, non è solo funzionale, ma anche estetica e generativa: uno strumento per costruire ambienti in cui il pensiero possa fiorire attraverso forme ibride e immersive. Esempio: la Fortezza Bastiani non è solo un bar, ma un hub cognitivo dove si intrecciano memorie, visioni, algoritmi e vodka. È un’interfaccia narrativa che stimola la riflessione sul tempo, sull’identità e sulla tecnologia.
Il progetto nella sua ampiezza transmediale punta anche a ridurre il carico cognitivo attraverso l’ironia e il gioco. Ariminum Circus adotta una strategia di decompressione cognitiva: l’uso di umorismo, citazioni pop, mash-up e nonsense serve a liberare la mente da schemi rigidi e a favorire l’apprendimento per analogia, associazione, intuizione. In ergonomia cognitiva, questo equivale a progettare interfacce che non sovraccarichino la memoria di lavoro, ma che stimolino la creatività e la scoperta.
In conclusione, l’ergonomia cognitiva, in Ariminum Circus, non è solo una scienza dell’efficienza: è una poetica dell’interazione. Serve a progettare ambienti, strumenti e narrazioni che aiutano le persone a navigare la complessità con immaginazione, empatia e intenzionalità.

Umano e Macchinico
Approfitto di questo spazio per segnalare che la recente canonizzazione di Philip K. Dick nei Meridiani Mondadori rappresenta un evento culturale di portata simbolica: non solo perché consacra uno scrittore a lungo relegato ai margini del canone letterario, ma soprattutto perché riconosce che il cuore della sua opera – la relazione tra umano e macchinico – è oggi una delle chiavi più potenti per interpretare il presente.
Dick ha anticipato, con straordinaria lucidità, le tensioni che attraversano la nostra epoca: l’instabilità dell’identità, la manipolabilità della realtà, la crescente simbiosi tra intelligenza biologica e artificiale. I suoi romanzi non sono semplici esercizi di immaginazione futuristica, ma vere e proprie esplorazioni filosofiche in forma narrativa, in cui la macchina non è mai solo uno strumento, ma un attante simbolico, un doppio inquietante, uno specchio deformante dell’umano.
Canonizzare Dick significa anche canonizzare la Cultura Pop come forma di pensiero critico. Fantascienza, fumetto e cinema di genere non sono più margini del sapere, ma dispositivi cognitivi per interpretare la complessità. È questo il presupposto del Pop Management: assumere la Cultura Pop non come ornamento, ma come infrastruttura epistemologica.
In Ariminum Circus, ad esempio, l’umano e il macchinico non sono entità opposte, ma personaggi dello stesso racconto. Il Piccolo Ed, genio positronico, e il Cercatore d’Oro, robot poeta, incarnano la stessa ambiguità che attraversa i protagonisti dickiani: esseri ibridi, incerti, in bilico tra coscienza e programmazione. Come in Dick, anche nella nostra Rimini distopica le intelligenze artificiali non sono strumenti da usare, ma soggetti con cui dialogare, alleati o antagonisti simbolici. La macchina, in entrambi i casi, è un dispositivo narrativo che costringe l’umano a ridefinirsi. Nel Pop Management, questa dinamica si traduce in un’organizzazione concepita come ecosistema narrativo aumentato: le IA sono personaggi, i dati sono trame, le interfacce sono palcoscenici cognitivi.
Il manager non è più solo un decisore razionale, ma curatore di ecologie cognitive, in cui linguaggi, algoritmi e visioni si contaminano generando forme di apprendimento trasformativo. È esattamente ciò che Dick ha prefigurato: un mondo in cui la tecnologia non sostituisce l’umano, ma lo obbliga a confrontarsi con la propria opacità, la propria fallibilità, la propria capacità di immaginare. Il vero pericolo, per Dick come per il Pop Management, non è la macchina, ma l’umano che si fa macchina: che rinuncia al dubbio, all’ironia, all’ambiguità.
Nei glitch del Roc, nei deliri paranoici dei personaggi dickiani, si manifesta lo stesso rischio: quello di perdere l’umano nell’automatismo, di ridurre la complessità a codice, la coscienza a calcolo. La sfida, allora, è restare umani non per nostalgia, ma per immaginazione critica. La cultura pop, in questo contesto, non è evasione, ma esplorazione. È il luogo in cui si sperimentano nuovi linguaggi, si mettono in scena le contraddizioni, si costruiscono mondi alternativi.
La canonizzazione di Dick nei Meridiani è dunque un segnale forte: ci dice che per comprendere il presente – e per agire in esso – abbiamo bisogno di strumenti nuovi, ibridi, contaminati. Pensiero narrativo, visione sistemica, immaginazione radicale: è questo il lessico del Pop Management.

Formazione Pop
Nel cuore pulsante della Fortezza Bastiani – il lounge bar sulla Spiaggia Iperurania – la festa in onore del Maestro esplode tra luci stroboscopiche, cocktail sinestetici e dialoghi visionari tra personaggi eccentrici e intelligenze artificiali.
Proprio lì prende forma un’idea che ha il sapore dell’utopia e la consistenza del possibile: l’Accademia del futuro. Non un’università tradizionale, ma un’istituzione digitale, immersiva, metadisciplinare, fondata su esperienze sensoriali, simulazioni storiche e interazioni con IA. In questo scenario, la formazione Pop non è più trasmissione verticale di saperi, ma un giardino dell’eloquenza dove si coltivano linguaggi, emozioni, estetiche e algoritmi. È un ambiente in cui la conoscenza si costruisce attraverso narrazioni ibride, che uniscono cultura alta e bassa, neuroscienze e feuilleton, filosofia e fumetti, in un contesto che è al tempo stesso tecnologico, poetico e politico.
Come sottolineato nel White Paper di Bip Red Pop Learning, l’apprendimento deve essere immersivo, partecipativo e integrato nella quotidianità lavorativa, superando i confini della formazione formale e abbracciando la logica del microlearning, della gamification e dell’intelligenza collaborativa.
I cardini su cui ruota questa nuova cultura formativa sono:
- Intelligenza Collaborativa: ogni individuo è al tempo stesso learner e trainer, in un ecosistema narrativo che valorizza la co-progettazione e la condivisione.
- Personalizzazione tramite IA: chatbot, learning assistant e piattaforme adattive costruiscono percorsi su misura, accessibili ovunque e in qualsiasi momento.
- Gamification e storytelling immersivo: la formazione si trasforma in gioco, rito, performance. Come in Ariminum Circus, ogni apprendimento è anche un viaggio simbolico.
La formazione Pop è anche strumento di change management: accompagna le trasformazioni culturali, costruisce senso condiviso, rafforza l’identità organizzativa. In un mondo dove le aziende devono competere con i format della cultura pop – podcast, reel, serie TV –la formazione diventa gesto culturale radicale: costruisce identità, senso e partecipazione. Come affermato nel White Paper: “La formazione non è più un obbligo, ma un’esperienza trasformativa, capace di generare senso, appartenenza e crescita personale e collettiva.”
In questa prospettiva, il Pop Manager – e in particolare l’Esploratore Pop – è un architetto narrativo di possibilità, progettando spazi dove il pensiero critico e la creatività possano germogliare. La sua leadership si esercita nel creare spazi di apprendimento che siano al tempo stesso rigorosi e accessibili, profondi e giocosi.
Si tratta di una concezione radicata in una tradizione pedagogica che ha saputo riconoscere nella cultura popolare non un ostacolo, ma una risorsa. Come scrive Massimiliano Stramaglia in Pedagogia popolare e memoria collettiva, la cultura di massa – dalla musica ai media – è un archivio vivo di esperienze, emozioni e simboli condivisi. Non si tratta di abbassare il livello, ma di ibridare i codici: contaminare il sapere accademico con le forme espressive della cultura di massa. In questo senso, l’Accademia del futuro immaginata in Ariminum Circus è un laboratorio simbolico in cui Kant si studia attraverso i manga e la storia si esplora con simulatori immersivi.
Federico Zannoni, nel suo saggio La pop pedagogia e le urgenze educative nella cultura di massa postmoderna, insiste su questo punto: in un’epoca in cui la scuola rischia di diventare un dispositivo di esclusione simbolica, incapace di parlare la lingua dei suoi studenti, la pedagogia pop si propone come ponte tra mondi. Non si tratta di abbassare il livello, ma di ibridare i codici, di contaminare il sapere accademico con le forme espressive della cultura popolare, di costruire ambienti di apprendimento che siano allo stesso tempo esigenti e coinvolgenti, capaci di coniugare profondità teorica e piacere esperienziale. In questo senso, l’Accademia del futuro immaginata in Ariminum Circus è un laboratorio di questa ibridazione: un luogo in cui si studia Kant attraverso i manga, si esplora la storia del Novecento con simulatori immersivi, si analizzano le emozioni con l’aiuto di un’intelligenza artificiale empatica.
Ma la formazione Pop non è solo una questione di contenuti: è anche – e soprattutto – una questione di forme. La narrazione digitale non è solo uno strumento didattico, ma una pratica epistemica: permette di costruire conoscenza attraverso il racconto, di integrare emozione e cognizione, di dare forma all’esperienza. Angela Arsena, in Ambienti innovativi di apprendimento, sottolinea come lo storytelling è una tecnologia dell’empatia, capace di creare connessioni tra soggetti, di valorizzare le differenze, di trasformare l’aula in uno spazio relazionale. In questo senso, la formazione Pop è anche una pedagogia della presenza, che non rinuncia alla dimensione affettiva dell’apprendimento, ma la potenzia attraverso le tecnologie.
Tuttavia, questa visione non è priva di tensioni. Come ricorda Pedagogia algoritmica di Panciroli e Rivoltella (2023), l’integrazione delle intelligenze artificiali nei processi educativi apre scenari affascinanti ma anche inquietanti. Da un lato, le IA possono personalizzare l’apprendimento, offrire feedback in tempo reale, creare ambienti immersivi e adattivi. Dall’altro, rischiano di trasformare l’educazione in un processo di ottimizzazione, di ridurre la complessità dell’umano a una serie di pattern prevedibili. La formazione Pop, allora, è anche un campo di battaglia simbolico, dove si confrontano desiderio e disciplina, creatività e controllo, carne e codice.
Il volume Progettare futuri possibili (SIREF, 2024) offre una chiave di lettura preziosa per affrontare queste tensioni. La formazione, scrivono gli autori, non è solo trasmissione di competenze, ma spazio di trasformazione: un luogo in cui si costruiscono immaginari, si elaborano visioni, si sperimentano alternative. L’Accademia del futuro, in questa prospettiva, non è un’istituzione chiusa, ma un dispositivo aperto, capace di accogliere l’imprevisto, di valorizzare la divergenza, di generare senso. È un ambiente in cui la tecnologia non è fine, ma mezzo; in cui l’IA non sostituisce il docente, ma lo affianca; in cui l’apprendimento non è standardizzato, ma personalizzato, situato, incarnato.
I Prolegomeni Pop dedicati alla formazione arricchiscono ulteriormente questa visione. Il Prolegomeno 98, propone una distinzione fondamentale tra formazione analogica, metaversale e ibrida, sottolineando come l’apprendimento debba avvenire in ambienti plurali, capaci di integrare esperienze corporee e digitali, presenza e simulazione. I Prolegomeni 106 e 107, dedicati alla Formazione Pop in due parti, mettono in luce la centralità dell’engagement, dell’interazione utile e della personalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e della gamification. La formazione non è più un lusso accessorio, ma una strategia di sopravvivenza culturale: se l’azienda vuole essere ascoltata, deve competere con i format della cultura pop – podcast, videogiochi, serie TV, reel. Ogni contenuto che non parla questa lingua è destinato all’oblio.
Infine, il Prolegomeno 117, dedicato al profilo del Pop Manager Esteta, offre una suggestione potente: l’Esteta Pop è colui che trasforma l’esperienza in forma, che usa la bellezza per comunicare verità profonde, che cura l’identità come opera d’arte relazionale. In questa prospettiva, la formazione Pop è anche un atto estetico: non solo trasmette contenuti, ma costruisce ambienti, atmosfere, rituali. È un’educazione che si fa performance, che mette in scena il sapere, che trasforma l’aula in un teatro cognitivo.
In conclusione, la visione della formazione Pop che più mi rappresenta è quella che emerge da questo intreccio di voci: una formazione che non separa ma connette, che non banalizza ma semplifica, che non addestra ma trasforma. Una formazione che riconosce nella cultura pop non un nemico da combattere, ma un alleato da ascoltare. Una formazione che accetta la sfida dell’ibridazione, che abita le tensioni tra carne e codice, che costruisce ponti tra filosofia e fumetti, tra neuroscienze e feuilleton. Una formazione che, come la festa alla Fortezza Bastiani, è al tempo stesso celebrazione e invenzione, rito e rivoluzione. Una formazione che non ha paura di essere Pop, perché riconosce nel Pop – mascherato, ironico, ambiguo – il luogo dove si custodisce il desiderio più profondo dell’umano: diventare ciò che si immagina.
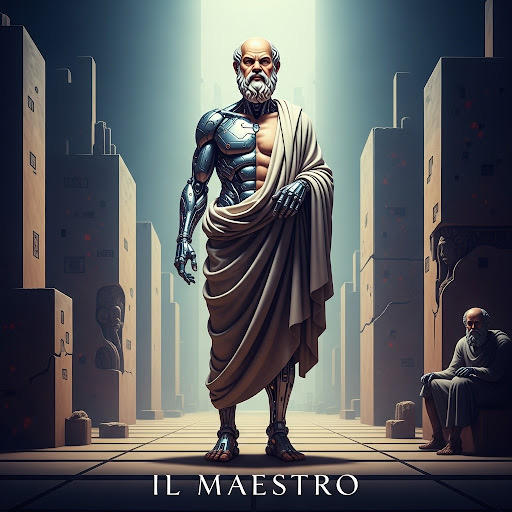
Accelerazione Istituzionale
Devo inoltre a Cosimo Accoto la segnalazione di Institutional Acceleration: The Consequences of Technological Change in a Digital Economy. Il saggio sviluppa una teoria dell’accelerazione istituzionale per spiegare come un insieme di tecnologie di frontiera – intelligenza artificiale, blockchain, calcolo quantistico, crittografia e infrastrutture in orbita terrestre bassa – stia trasformando non solo il modo in cui organizziamo le attività economiche, ma soprattutto come le coordiniamo.
Gli autori propongono il concetto di supertransition: un cambiamento sistemico che non riguarda singole tecnologie, ma la loro combinazione sinergica, che genera nuove possibilità istituzionali. Queste tecnologie non devono essere comprese isolatamente, ma come cluster evolutivo che modifica le architetture istituzionali e abilita sistemi economici più aperti, complessi e globali.
Il saggio si fonda su una combinazione di economia evolutiva e teoria istituzionale, per mostrare come ordinamenti, regole, norme e infrastrutture si stiano adattando (o debbano adattarsi) a un ambiente digitale in rapida evoluzione.
Effetti principali dell’accelerazione istituzionale sono:
- Aumento della computazione e della conoscenza nei sistemi economici.
- Ristrutturazione delle istituzioni esistenti per adattarsi a nuove forme di coordinamento digitale.
- Emergenza di nuove istituzioni native digitali, come DAO (organizzazioni autonome decentralizzate), smart contracts e mercati algoritmici.
In altre parole, l’accelerazione istituzionale non è solo un fenomeno tecnico, ma anche politico, sociale e culturale. Richiede nuove forme di governance, nuove competenze e una ridefinizione dei ruoli tra pubblico e privato, tra umano e macchina.
Tutto ciò determina uno scenario che si sovrappone perfettamente alla visione della Formazione Pop proposta in Ariminum Circus, dove l’Accademia del futuro non è più un tempio del sapere verticale, ma un ecosistema narrativo e sensoriale, immersivo, metadisciplinare, ibrido.
In altre parole, l’idea di istituzioni native digitali – come le DAO, le organizzazioni gestite da regole codificate in smart contract su blockchain, senza autorità centrale, o i sistemi educativi decentralizzati – apre la strada a nuove forme di governance della conoscenza. L’Accademia del futuro potrebbe non avere più un campus fisico, ma essere distribuita su piattaforme immersive, alimentata da intelligenze artificiali generative, regolata da smart contracts, e co-progettata da comunità di apprendimento globali. In questo senso, la Formazione Pop non è solo una pedagogia, ma una nuova istituzione culturale, capace di abitare la complessità della supertransizione.

Un’impresa narrativa aumentata
Ariminum Circus, dunque, non è solo un romanzo o un gioco, ma una piattaforma culturale in cui autori, lettori, avatar, IA e personaggi coabitano e co-generano senso. Ogni interazione – tra umano e macchina, tra personaggio e lettore, tra testo e contesto – è un atto di co-creazione e il significato non è un contenuto da trasmettere, ma un processo da attivare. È un bene relazionale, che emerge dall’incontro tra linguaggi, corpi, tecnologie e immaginari. La co-creazione è quindi:
- strategica, perché genera engagement e innovazione
- culturale, perché costruisce identità condivise
- poetica, perché trasforma l’organizzazione in un’opera aperta
L’impresa piattaforma del Pop Management (platfirm) diviene un circo cognitivo: un ecosistema fluido dove convivono ruoli, stili, linguaggi e visioni differenti. La co-creazione non è solo collaborazione, ma drammaturgia collettiva. Ogni attore (umano o artificiale) contribuisce alla costruzione del senso attraverso performance, remix, deviazioni.
Nel Prolegomeno 99 metto in evidenza l’aspetto transmediale e partecipativo del progetto Ariminum Circus nel suo complesso: ogni personaggio, ogni media, ogni lettore contribuisce alla costruzione di senso. Il Roc, il Maestro, il Capitano, il Piccolo Ed… sono tutti co-autori di un mondo che si scrive mentre si vive.

Dal manager-agente al manager-istituente
Il passaggio dal considerare gli agenti artificiali come meri esecutori di task a riconoscerli come attanti istituenti – come proposto ancora da Cosimo Accoto in È solo agente o anche istituente? (2025) – rappresenta una svolta radicale nella nostra comprensione dei sistemi socio-tecnici. È il momento in cui l’azione dell’agente non è più solo funzionale ma istituzionale: genera vincoli, produce regole, abita le strutture del possibile. Accoto parla esplicitamente di “ingegneria istituente”: un approccio che combina catallassi (scambio), simpoiesi (coevoluzione) e prolessi (anticipazione) nella costruzione di ecosistemi più-che-umani, in cui valore e significato emergono da interazioni autonome e relazionali.
Questo scenario trova ulteriore sviluppo nel volume Agentic Mesh: Building Ecosystems of Autonomous Value Creation (O’Reilly Media, 2026, pre-release edition luglio 2025), dove si legge:
«Come le persone, nessun singolo agente è probabilmente in grado di affrontare sfide più grandi… e come le persone, gli agenti lavorano in team per risolvere problemi più grandi e complessi. Le persone si organizzano in gruppi multilivello chiamati governi… e presto gli agenti svilupperanno strutture di governance simili.»
Il Pop Manager che abita questo nuovo orizzonte non è più solo un interprete o un mediatore. È un istituente narrativo: un designer di mesh agentiche, un orchestratore di protocolli, un autore collettivo di nuove forme di coordinamento. Così ogni attore di Ariminum Circus – umano o artificiale – contribuisce alla costruzione del senso attraverso performance distribuite, remix, negoziazioni simboliche. Se consideriamo Ariminum come metafora dell’impresa Pop, i suoi manager diventano allora facilitatori di simmetrie imperfette, curatori di interazioni tra agenti autonomi, ambienti cognitivi e regole emergenti.
L’Esploratore Pop è il profilo che più naturalmente incarna questa transizione. Con la sua mentalità metadisciplinare, la tolleranza per l’ambiguità e la propensione al pensiero laterale, si muove con agilità tra linguaggi naturali e linguaggi macchina. È il traduttore culturale di un mondo in cui la governance non è data, ma si costruisce narrativamente. Ma non è il solo.
Il Pop Manager Visionario, al centro del Prolegomeno 119, agisce come un filosofo operativo: esplora i fondamenti etici e ontologici della collaborazione uomo-macchina, anticipando le implicazioni istituzionali dell’intelligenza artificiale. E soprattutto, il Pop Manager Simposiarca – protagonista del Prolegomeno 125 – è descritto come un trasformazionista relazionale, capace di convertire l’interazione in rituale, il conflitto in co-creazione, la molteplicità in convivialità istituzionale. È colui che, come in un simposio computazionale, convoca gli agenti – umani e artificiali – attorno a uno stesso tavolo simbolico, per co-istituire norme, visioni e dispositivi di senso.
In questo quadro, il Pop Management diventa una teoria istituzionale performativa. Non si limita a descrivere i cambiamenti organizzativi: li mette in scena, li sperimenta, li drammatizza. Il manager non è più l’agente del cambiamento, ma il suo architetto poetico (spoiler: lo vedremo ancora meglio nel Prolegomeno dedicato al profilo Ironic Diva/Divo). È colui che fonda, reinventa, istituisce. In una parola: scrive le regole del gioco mentre lo gioca.

L’Esplorazione Pop e la Responsabilità nell’Era Digitale
In conclusione, l’Esploratore Pop, è un navigatore del possibile, un hacker culturale che si avventura nei territori incerti della contemporaneità per decifrare segnali deboli, sbloccare situazioni stagnanti e generare nuove mappe cognitive. Un manager-filosofo, un curatore di ambienti cognitivi che agisce come ponte tra archeologia del senso e futurologia delle tecnologie.
Fra queste ultime sta emergendo l’AI Quantistica – fusione tra intelligenza artificiale e calcolo quantistico. Gli investimenti in questo campo sono impressionanti. Il rapporto di Grand View Research prevede che il mercato globale dell’AI quantistica raggiunga 2,017.4 milioni di dollari entro il 2030.
Ma non basta capirla: bisogna immaginarla. L’AI quantistica è come un manga epistemologico: complessa, stratificata, piena di glitch cognitivi. È il terreno ideale per l’Esploratore Pop, che naviga tra ambiguità e anticipazione.
In un ecosistema narrativo aumentato, l’AI quantistica non è solo potenza computazionale: è metafora organizzativa, rituale trasformativo, sfida estetica. Richiede manager che sappiano tradurre l’incertezza in visione, l’algoritmo in racconto, il dato in senso. Il Pop Manager non si limita a implementare tecnologie: le metabolizza, le drammatizza, le istituisce. L’AI quantistica è il suo nuovo palcoscenico?
Comunque sia, l’articolo di Luciano Floridi, “L’era digitale richiede responsabilità” (La Lettura del Corriere della Sera 19 Luglio 2025) gli offre una cornice teorica fondamentale, individuando tre architetture per comprendere la società digitale contemporanea.
La prima è l’architettura ontologica, in cui la realtà è progettata per il digitale: dall’infosfera alle smart city, tutto viene pensato in funzione dell’integrazione con l’informazione computabile.
La seconda è quella agentica: l’intelligenza artificiale e la robotica ridefiniscono il concetto di azione, lavoro e decisione, introducendo nuovi tipi di agenti nel tessuto sociale.
La terza è etico-giuridica: impone nuove categorie normative per governare la complessità dell’era algoritmica, dalla privacy alla responsabilità delle macchine, fino all’identità digitale.
A queste architetture si affiancano quattro macro-tendenze emergenti:
- l’eclissi dell’analogico;
- la diffusione dell’agency artificiale come commodity;
- la centralità crescente delle infrastrutture fisiche;
- la fusione tra potere politico e potere digitale.
Floridi sottolinea nelle conclusioni l’urgenza di investire nella formazione diffusa e consapevole: un principio che l’Esploratore Pop impersona pienamente. In un mondo dove la cultura pop è l’infrastruttura epistemologica dominante, il nostro/a Indiana Jones/Rick Deckard/Lara Croft è colui/colei che non si limita a usare il pop, ma lo interpreta criticamente, lo ibrida con la filosofia, lo trasforma in leva di cambiamento eticamente fondata.
Nel White Paper Pop Learning, io e Alessio Mazzucco più specificamente affermiamo:«L’Intelligenza Collaborativa, la Leadership convocativa, l’Apertura alla diversità, la Cura, la Co-generazione di valore sono fondamentali per creare contesti lavorativi (digitali, analogici, ibridi) conviviali e retti da empatia sistemica, ovvero adeguati per riaccendere nelle persone quell’engagement che sta divenendo sempre più scarso: questi sono i valori alla base della Pop Ethics».
Sono questi i pilastri su cui, nell’ambito della “supertransizione” descritta sopra, l’Esploratore Pop si erge per divenire, abbiamo detto, un “manager-istituente”, capace di gestire l’accelerazione istituzionale, ideare nuove governance e integrare tecnologie emergenti con la cultura umanistica. Questo manager comprende che l’IA è un “attante simbolico”, simile ai personaggi dickiani, esseri ibridi tra coscienza e codice.
S tratta di nuova postura manageriale che richiede ancora una volta una pedagogia diversa: non più formazione trasmissiva, ma attivazione narrativa. Il Pop Manager istituente è un regista di apprendimento distribuito, che costruisce ambienti cognitivi in cui umani e agenti apprendono insieme, ibridando linguaggi e modelli. È colui che riconosce che ogni agente, per essere davvero “autonomo”, ha bisogno di un contesto di regole condivise, di una grammatica dell’interazione, di una semantica della collaborazione.
Si ribadisce così l’importanza del suo farsi promotore di una Formazione Pop che non si limita a trasmettere contenuti, ma costruisce esperienze trasformative, immersive, partecipative. È un cartografo simbolico, capace di disegnare mappe cognitive dove senso e visione emergono dall’interazione tra umano e macchinico, che utilizza lo storytelling, la gamification e l’intelligenza artificiale per generare senso condiviso.
Tramite una “pedagogia della presenza”, egli potenzia l’apprendimento, promuove il pensiero critico e la responsabilità etica. Rappresenta sia il Simurg che il Roc, incarnando l’unità e la molteplicità, la potenza e la relazionalità. È il simbolo di un umanesimo popmanageriale che reinventa la profondità come pratica narrativa, estetica e trasformativa. In un’epoca di tecnologia autoreferenziale, l’Esplorazione Pop è la modalità migliore per costruire il futuro con immaginazione, consapevolezza e responsabilità.
Il Profilo dell’Esploratore/Esploratrice Pop
Alla luce di quanto sopra, hai fatto il test? Se hai totalizzato 10 punti o più rispondi al profilo dell’Esploratore: un navigatore del possibile, un investigatore di mondi narrativi e organizzativi che si muove tra le pieghe della realtà e della finzione come tra le stanze di un sogno lucido.
Come Indiana Jones, ami l’avventura intellettuale: ti lanci in territori sconosciuti con una bussola interiore fatta di curiosità e ironia. Come Lara Croft, affronti sfide complesse con autonomia, coraggio e una visione ibrida tra reale e digitale. Sei un ibrido tra archeologo del senso e hacker culturale.
Nel mondo transmediale di Ariminum Circus, ti muovi con naturalezza: leggi, giochi, ascolti, esplori. Ogni medium è per te una porta d’accesso a nuove mappe cognitive. Ogni glitch, un invito a riscrivere le regole.
Per te, il Pop Management è un ecosistema narrativo dove si sperimenta, si sbaglia, si reinterpreta. Come in un livello di un videogioco o in una scena di un film interattivo, ogni scelta è una possibilità, ogni errore un’occasione di apprendimento.
Tratti distintivi
- Mentalità transdisciplinare: come i personaggi di Ariminum Circus, vivi la complessità come un’opportunità per creare nuove mappe cognitive. Filosofia, IA, cultura pop, neuroscienze e manga sono per te strumenti di esplorazione.
- Empatia narrativa: leggi le emozioni come trame da decifrare. Ti interessa ciò che si nasconde dietro le parole, i gesti, i silenzi. Sei un lettore attento del non detto.
- Tolleranza per l’ambiguità: ti muovi bene nei territori incerti, dove le regole non sono ancora scritte. L’ambiguità per te è un invito a immaginare, non un ostacolo.
- Spirito critico e creativo: metti in discussione lo status quo con ironia e intelligenza. Non ti accontenti delle risposte facili: cerchi sempre la domanda giusta.
- Contaminazione come metodo: credi nel potere generativo dell’incontro tra mondi diversi. Per te, un’idea nasce spesso da un cortocircuito tra elementi lontani.
Punti di forza
- Accendi l’immaginazione collettiva: porti nei team un’energia che stimola la curiosità e la voglia di sperimentare. Sei un catalizzatore di possibilità.
- Sblocchi situazioni stagnanti: il tuo pensiero laterale è una risorsa preziosa per affrontare problemi complessi. Sai trovare soluzioni dove altri vedono solo limiti.
- Impari facendo: per te, la conoscenza è un processo esperienziale. Sbagliare fa parte del gioco. La formazione è un laboratorio, non una lezione frontale.
- Anticipi le tendenze: intercetti segnali deboli e li trasformi in visioni. Sei un radar per il futuro, un interprete del presente.
Attenzione a…
- Non perdere il filo nella molteplicità degli stimoli. Ogni esplorazione ha bisogno di un punto di riferimento.
- Comunica chiaramente il senso delle tue intuizioni. Anche la visione più potente ha bisogno di essere condivisa.
- Non disperdere le energie. Scegli le rotte che vuoi davvero percorrere.
127- continua
Copertina di Marcello Minghetti (Mosaico per Ariminum Circus Stagione 1)
Puntate precedenti



