Quando un’epoca si sgretola, lo fa prima nelle immagini che nelle statistiche. Prima nei simboli che nei report trimestrali. Il Pop Opinionist Nello Barile lo sa bene: nel suo nuovo saggio Deglobalizzazione – Immagini di un mondo in frantumi (Egea, 2025), il sociologo dei media non ci offre l’ennesima analisi economica del declino globalista, ma qualcosa di più radicale e necessario: una mappa dell’immaginario che stiamo perdendo, o forse che stiamo finalmente abbandonando.
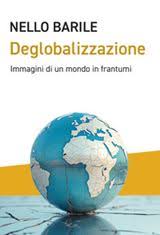
Per chi pratica il management come forma di intelligenza collaborativa – e non come esercizio di controllo gerarchico – questo libro è un elettroshock salutare. Barile ci mostra come la promessa di una rete globale e aperta si sia trasformata in un mosaico di bolle comunicative, come la tecnologia che doveva connetterci ci abbia isolati in tribalismi digitali, come il potere si sia fatto cognitivo, esercitato attraverso algoritmi e persuasione invisibile.
Sono le stesse contraddizioni che attraversano le nostre organizzazioni: il paradosso delle piattaforme collaborative che generano silos; l’intelligenza artificiale che promette efficienza ma erode autonomia critica; la spettacolarizzazione della leadership che riduce il dissenso a intrattenimento. Il management, come la globalizzazione, non scompare: si decompone e si replica in nuove forme di potere.
Questa conversazione nasce da una convinzione: che per ripensare il management contemporaneo dobbiamo prima capire quale immaginario del mondo stiamo abitando. E Barile, con il suo atlante visivo delle crepe del presente, ci offre gli strumenti per farlo.
MM Nel tuo libro descrivi la deglobalizzazione come “disgregazione di un immaginario comune” più che come semplice arretramento economico. Nel management stiamo vivendo una frattura simile? L’immaginario della “leadership globale” e delle “best practices universali” si sta frantumando negli stessi termini che descrivi per la geopolitica?
NB Da non addetto ai lavori posso dire che siamo passati da un’epoca utopica, ad una pragmatica a una distopica o retrotopica. In principio era la globalizzazione che è stata preparata dall’internazionalizzazione fordista, per poi raggiungere il suo apice con il postfordismo, partendo dal modello Toyoka giapponese, fino alle più avanzate teorie del knowledge management anni alla Nonaka e Takeuchi.
Dalla seconda metà degli anni novanta il postfordismo supporta la glocalizzazione (Robertson 1992) grazie a un triplice processo tecnologico, organizzativo e comunicativo: 1) la rete diventa metafora dominante e principio assiale della nuova epoca grazie all’invenzione del world wide web che espande un principio fino ad allora elitario al grande pubblico globale; 2) le organizzazioni diventano sempre più flessibili, degerarchizzate e porose alle influenze dall’esterno (l’organizzazione ipertestuale e la conoscenza tacita che si trasforma in innovazione); 3) i brand scendono dal piedistallo e cercano di costruire un nuovo legame con il consumatore espandendosi sul suo sfondo esperienziale.
Questa triplice azione si potenzia con il passaggio agli anni duemila, alla sharing economy, alla società delle piattaforme e alla Quarta Rivoluzione industriale che elogia modelli aperti , leggeri e phygital alla Uber. L’attuale crisi della deglobalizzazione, che io analizzo soprattutto dal un punto di vista mediatico e geopolitico, potrebbe indurre a riconfigurare i principi delle organizzazioni globali. Non tanto nella direzione del reshoring, contemplata dai partiti populisti-sovranisti, come nei deepfake creati dai cinesi che ritraggono lavoratori americani obesi in nuove filiere fordiste, oppure Musk, Trump e Vance che assemblano tristemente sneakers in fabbriche veterofordiste.
La crisi potrebbe incentivare la sperimentazione di nuove soluzioni che non sono solo il ritorno alla cara vecchia produzione industriale rilocalizzata ma a probabilmente alla creazione di subaree di influenza che riconnettono in modo diverso i frammenti del vecchio mercato unificato globale.
MM Scrivi che “la rete non connette ma isola: moltiplica le voci ma dissolve la comunità”. Nelle organizzazioni usiamo Slack, Teams, piattaforme collaborative – ma stiamo davvero collaborando o replicando quella stessa frammentazione in bolle comunicative? Come distinguere tra connessione autentica e simulacro di collaborazione (vedi sul tema i post della serie Collaborazione Pop)?
NL Negli anni novanta, agli albori della glocalizzazione, la rete era uno spazio aperto, indeterminato, difficile da esplorare quasi come un tempo la vecchia frontiera americana del West. Ciò ispirava visioni anarcoidi e controculturali che difatti trasformavano le concezioni della cultura hippie in nuove attività di business. Ad esempio, tutto il discorso sul virtuale che domina gli anni novanta non è altro che la trasformazione della concezione psichedelica di creazione di realtà parallele, in un mondo informatico fatto di codici e di matrici numeriche.
Allo stesso modo la trasparenza si trasforma da valore comunitario e spirituale in requisito fondamentale della società delle piattaforme. Con l’unico problema che in tal modo si afferma una asimmetria tra l’utente che deve essere trasparente il più possibile, e le piattaforme che invece sono opache e balckboxed. Da un punto di vista politico, la creazione di bolle e di camere dell’eco determina il passaggio dalle ideologie alle omologie, in cui si tenta di creare legame tramite il rispecchiamento degli utenti nei medesimi valori e interessi, uccidendo la dialettica.
Con la diffusione dell’AI generativa, tale principio diventa ancor più preoccupante realizzando ciò che un tempo ho definito una condizione neototalitaria in cui l’intimità e la privacy sono messe a disposizione delle piattaforme (si pensi agli utenti che usano ChatGpt per una consulenza psicologica).
La trasparenza è sempre promossa dal lato dell’utente ma mai del tutto implementata dal lato del produttore. Ciò non vuol dire che queste tecnologie artificiali impediscano una connessione autentica, come anche nell’ambito lavorativo, ma possono creare grossi problemi su dimensioni più estese. Ad esempio è esemplare il caso di Deepseek, pubblicizzata come AI, low cost e open source, in Italia ha stretto accordi con il garante della privacy per tutelare gli utenti mentre in Australia è stato bandito per una questione di protezione dei cittadini. Se il capitalismo della sorveglianza delle piattaforme americane alla Zuboff, generava problemi di carattere esistenziale, economico e politico, con la deglobalizzazione o la riglobalizzazione verso Est, la questione dell’intimità e della privacy diventeranno sempre più geopolitiche.
MM Il passaggio “dal progressismo utopico della rete al feudalesimo delle piattaforme” che descrivi per la Silicon Valley – non è esattamente ciò che sta accadendo anche nelle strutture organizzative? I manager diventano feudatari di ecosistemi digitali, esercitando un “potere cognitivo” attraverso dashboard, KPI, algoritmi di valutazione?
NL Nel libro analizzo il film “Mickey 17” di Bong Joon Ho come metafora del nostro tempo. Non si tratta solo di una parodia distopica ma di una potente metafora del nostro tempo. Bong Joon Ho prende la colonizzazione interstellare e la trasforma in una distopia comica Il film mescola estetiche che spaziano dal retro-futuristico/steampunk al grottesco patafisico ispirato allo stile di Lanthimos (inclusa una comicità surreale data da Mark Ruffalo).
Il concetto chiave del film, però, è la questione dell’identità. Il protagonista viene continuamente ‘ristampato’ in 3D ogni volta che muore. È la quintessenza dell’usa e getta! Questo ci porta a chiederci: ‘Se posso essere riprodotto all’infinito, sono ancora un individuo?’ È una forma di immortalità iperconsumista. La morte viene ‘superata’ trasformando l’essere umano in una merce seriale, una forza lavoro per i compiti peggiori. Ironia della sorte, la cosa che cambia il finale è proprio un errore, un’anomalia in questa replicazione perfetta. Alla fine, il film ci fa riflettere se, per la sopravvivenza della specie, non sia più importante l’organismo collettivo che il singolo individuo.
Oltre a riproporre il tipico schema postcoloniale (dove gli alieni autoctoni sono i “buoni”), la questione centrale ruota attorno al protagonista, reso “sostituibile” grazie alla stampa biologica 3D. Questo meccanismo rappresenta una versione iperconsumista del “lungotermismo” in un contesto neofeudale, dove l’immortalità è raggiunta attraverso la riproduzione seriale dell’identità. Tuttavia, la serialità genera il problema di mantenere l’identità identica; un’alea, un errore di calcolo, è ciò che interviene, cambiando il corso della storia e portando a una risoluzione catartica. L’idea di superare la morte individuale attraverso la riproducibilità tecnica incessante (il protagonista è una “merce” seriale usata per lavori terribili) costringe a riconsiderare il futuro e la possibilità di un’eternità. Questo processo suggerisce che il superamento del valore dell’individuo potrebbe essere un passo evolutivo per la sopravvivenza della specie, che si proietta in avanti come un unico organismo.
L’immagine comune di tecnocrazia è quella di uno Stato-macchina hi-tech che controlla, predice e dirige le scelte dei cittadini, oggi sempre più attraverso il potere dei Big Data e degli analytics. Questa è una trasformazione epocale delle società avanzate che, in fase postindustriale, usano la tecnoscienza per governare e al contempo semplificare la complessità sociale.
In questo scenario, la cibernetica di Norbert Wiener, affiancata dalle teorie della complessità del Novecento, propose una nuova utopia pragmatica. In essa, il concetto di informazione è l’inverso dell’entropia (il disordine di un sistema). L’obiettivo di quest’utopia era innalzare l’efficienza del sistema (rapporto input/output) tramite l’uso pragmatico dell’informazione e la crescente potenza di calcolo. Questa visione è stata il fondamento teorico sia per chi supporta la svolta tecnocratica, sia per i suoi critici, che la vedono trasformarsi in una distopia nelle società avanzate.
Bernard Stiegler ha analizzato il passaggio da una società industriale ed entropica, dominata dalla macchina termodinamica, a una nuova società in cui Big Data e algoritmi pervadono ogni aspetto della vita, costituendo l’infrastruttura di una “società automatica” futura.
Il punto di svolta cruciale di questa transizione sono gli anni Novanta, con la nascita del World Wide Web, che ha gettato le basi per quella che Stiegler definisce la “farmacologia dei Big Data” e l'”industria delle tracce”. In questo processo, si assiste a una crescente proletarizzazione e all’espropriazione delle competenze, che oggi sono prevalentemente teoriche e creative, come già avvenuto in passato per le competenze fisiche. Le moderne tecnocrazie si sono evolute in una “nuova governance basata sulla cibernetica” e sulla “smartificazione” della società.
Mentre la cibernetica, secondo Martin Heidegger, punta all’unificazione del sapere tramite l’unità pragmatica dell’informazione, l’Organologia di Stiegler (una filosofia della tecnica avanzata) mira a riunificare il sapere attraverso il pensiero della differenza. L’Organologia unisce tecnica, biologia e organizzazione, riformulando la metafora positivista del corpo organico in termini di dispersione, differenza e molteplicità. Da ciò, deriva la constatazione che la tecnica è sempre presente in ogni dimensione dell’umanità (economica, estetica, psicologica, ecc.).
Il “potere cognitivo” dei manager come nuovi feudatari, attraverso dashboard, KPI, algoritmi di valutazione, a cui fai riferimento, sarà rafforzato dalle piattaforme e dagli LLM che sono capaci di trasformare dati qualitativi in quantitativi e viceversa. Se i teorici della ideologia californiana insistevano sul rapporto tra “cybrog padroni” e “robot schiavi” (Barbrook & Cameron 1996), il nuovo destino del cyborg, cioè dell’ibrido uomo/macchina, è quello di essere sottoposto a uno sfruttamento superiore a quello dei robot, da parte di una nuova élite di superuomini che protendono verso l’immortalità. Come nel film Elysium di Neill Blomkamp (2013).
MM Parli della contrapposizione tra paradigma globalista e paradigma identitario, tra Netflix Society e Retrotopia, tra pensiero Woke e reazione nostalgica. Nelle organizzazioni questa polarizzazione si traduce nello scontro tra innovazione a ogni costo e resistenza al cambiamento? Come può il management navigare questa “guerra metafisica” senza finire prigioniero di nessuno dei due estremi?
NL La questione è particolarmente scivolosa, dato che è associata a concetti nobili come quelli di inclusività, fluidità, sostenibilità, agency, wellbeing ecc. Essi in parte derivano dai movimenti controculturali degli anni sessanta e settanta ma si sono trasformati all’epoca delle piattaforme. Se fino all’intero arco degli anni novanta, essi esprimevano la potenza e l’irriverenza di una visione alternativa della realtà, oggi si sono trasformati in un nuovo mainstream e, attraverso la loro ripetizione e diffusione seriale, si sono svuotati del loro contenuto originario.
Entriamo in una fase paradossale che chiamo postfordismo dei diritti, in cui proprio le culture che un tempo si sono opposte al sistema del consumo globale e al postfordismo, ora adottano il medesimo principio per rivendicare la propria appartenenza a comunità, nicchie o pubblici diversificati, rivendicando la trasformazione dei propri desideri in diritti e realizzando su un livello diverso il sistema customer-centrico che è tipico delle piattaforme. L’acuirsi di processi di polarizzazione tra opposte visioni del mondo rende molto difficile il compito dell’uomo politico ma anche del manager. Anche perché la polarizzazione è quasi sempre vista come un processo portato avanti dalla parte avversa.
MM La “società artificiale” che preannunci – dove l’AI diventa “nuova metafisica del potere” promettendo efficienza in cambio di autonomia critica – è già qui nelle nostre organizzazioni. Come possiamo sviluppare quello che chiamo “collaborative intelligence” (vedi ad esempio i Prolegomeni su Intelligenza Collaborativa e Change Management in un contesto dove l’intelligenza artificiale rischia di diventare strumento di controllo piuttosto che di empowerment?
NL Negli anni novanta svettano concetti come quello di intelligenza collettiva (alla Levy), oppure connettiva (alla de Kerckhove). Poi siamo passati alla cocreazione al codesign, alla coopetition ecc. L’idea sostanziale è quella di superare il vecchio sistema di valori tipicamente “yang” come quello degli yuppie anni ottanta, basato sul capitalismo aggressivo, iperindividualista, ultracompetitivo ecc. con valori più “yin”, ovvero collaborativi, accoglienti, emozionali, ecc. per dirla alla F. Capra.
Tale trasformazione è stata mossa anche dal passaggio dalla globalizzazione alla glocalizzazione. Nel senso che la dimensione collaborativa tipica della piccola comunità localizzata, è stata incorporata nei modi di funzionamento delle multinazionali che, propio a causa dei movimenti di critica al sistema della globalizzazione, hanno provato a comunicare un’immagine di piccole comunità produttive (come ad esempio Nike, McDonald’s ma anche le multinazionali del lusso che mostrano artigiani che collaborano alla produzione delle loro borse).
L’avvento dell’AI dei LLM si sta sviluppando una integrazione dinamica tra le comunità produttive e le piattaforme all’insegna di una dimensione sempre più Phygital e customer-centrica. Che la tecnologia rappresenti un vantaggio capace di aumentare la dimensione collaborativa o semplicemente di simularla enfatizzando le separazioni e le differenze, dovrà essere studiato approfonditamente.
MM Concludi scrivendo che “riflettere sulla deglobalizzazione vuol dire ripensare il modello che ha tradito molte delle sue promesse”. Quale modello di management ha tradito le sue promesse? E quali immagini – quali nuovi immaginari – possono aiutarci a costruire organizzazioni più umane, più resilienti, più capaci di affrontare un mondo in frantumi?
NL Direi che il mondo contemporaneo è spaccato tra due opposti scenari e/o immaginari: uno ancora utopico e grassroots, l’altro più dispotico e top-down.
Il primo scenario richiama il l’utopia dei fablabs, con il loro ripensamento del sistema capitalistico dal basso, promosso da micro-comunità produttive localizzate. Il movimento dei Makers è cresciuto superando il “dualismo digitale” grazie ai progressi tecnologici nella fabbricazione rapida tramite stampanti 3D, trasformando produzione, consumo e creatività in un mondo neo-artigianale. Questo processo crea un capitale emotivo che lega intimamente creatore e prodotto, intensificato dalla condivisione nei FabLab.
Dall’iniziale “amatorialità” dei Makers si è passati più recentemente a una assorbimentio di tale modello da parte delle grandi aziende (che non delocalizza geograficamente, ma sposta il ruolo di produttore sui consumatori sfruttando il loro potenziale creativo). Il piacere intrinseco della creazione, unito al desiderio di connessione, guida i Makers dall’espansione grassroots all’integrazione in programmi come Industria 4.0. Questo modello produttivo multilocalizzato e open source potrebbe offrire una risposta più agile alle attuali sfide della globalizzazione, anche grazie alla diffusione della AI generativa.
Il secondo scenario è invece quello in cui il legame tra economia e geopolitica si trasforma in una sorta di cavallo di troia capace di rilevare e poi assoggettare i distretti produttivi europei, esportando il modello cinese al di fuori dei propri confini. Ne è un esempio il possibile accordo tra la multinazionale Dongfeng Motor e la Regione Piemonte il rilevamento di tre siti produttivi nei quali potrebbero insediarsi nuove attività legate al mercato delle auto elettriche.
Al di là degli stereotipi che possono rientrare nella percezione della vicenda, l’asimmetria dei rapporti di potere tra i soggetti coinvolti nell’eventuale negoziazione, suggerisce una grande cautela nei confronti di un’operazione che non ha solo un significato economico ma anche, ovviamente, geopolitico.
146 – continua
Puntate precedenti



