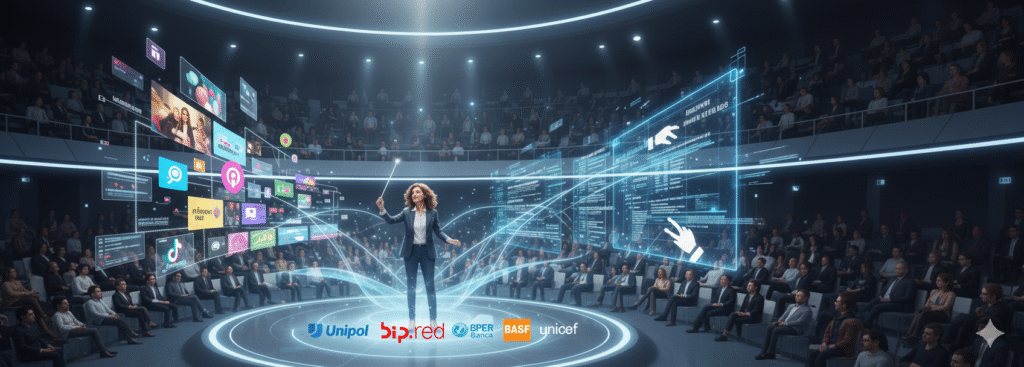Brand Forward
“Brand Forward: l’evoluzione dei brand, fra algoritmi e autenticità” è il terzo appuntamento sul Pop Branding dopo gli eventi di Milano e Torino.
Si terrà il prossimo 5 novembre presso la Bologna Business School dalle ore 18.00. Per iscriverti clicca qui.

Come di consueto, l’evento sarà una Conversazione Collaborativa. Di cosa parleremo? E con chi?
Partiamo dall’assunto canonico del Pop management: podcast, serie TV, reel e format digitali hanno ridefinito l’arena della comunicazione. In questo ecosistema iperconnesso, le aziende non competono più soltanto tra loro, ma con l’intero universo dell’intrattenimento per conquistare l’attenzione – e soprattutto il tempo – delle persone. È qui che prende forma la Pop Communication: una dimensione in cui il linguaggio del brand si fonde con quello della cultura, e dove l’impresa è chiamata non più solo a vendere, ma a produrre senso.
Oggi un marchio non si costruisce a colpi di campagne, ma attraverso narrazioni che sappiano ispirare, coinvolgere e attivare. Il pubblico non è più un bersaglio da raggiungere: è una comunità che partecipa, commenta, reinterpreta. Per questo, le aziende più consapevoli stanno passando da un modello di comunicazione “revocativo”, centrato sul messaggio, a uno “convocativo”, fondato sulla relazione (vedi 71 – LEADERSHIP POP. APOFATICA E CATAFATICA DELLA COMUNICAZIONE). Ogni interazione, dal punto vendita ai social, può diventare un momento di autentica Collaborazione Pop.
Ma in un contesto dove la tecnologia e in particolare l’intelligenza artificiale produce una quantità potenzialmente infinita di contenuti, emerge una domanda cruciale: come mantenere la centralità del fattore umano? La vera distintività non risiede più nella sola qualità del prodotto, ma nella capacità del brand di agire come curatore di cultura, di generare valore condiviso e followership consapevole.
Costruire un’identità oggi significa accettare la sua fluidità, riscrivere le regole a seconda dei contesti, raccontare le stesse storie in modi sempre nuovi. È nel “retelling” – nella capacità di rimettere in circolo i simboli, adattandoli alle sensibilità del momento – che un brand può diventare parte dell’immaginario collettivo (vedi su questo 91 – INNOVAZIONE POP. REMIX, RI-USO, RETELLING)
A partire da queste premesse, abbiamo posto cinque domande a responsabili marketing di imprese e organizzazioni molto diverse per natura e linguaggio – Unipol, BPER Banca, UNICEF, BASF e Bip Red – per esplorare come la comunicazione d’impresa possa trasformarsi in una nuova forma di cultura partecipata. Saranno loro gli animatori dell’evento del 5 novembre.
- Dal marchio al simbolo culturale
Per Sabrina Bianchi (BPER Banca), un brand diventa un simbolo culturale “quando riesce a restituire valore alla società, andando oltre la logica del prodotto per diventare parte attiva del cambiamento”. L’iconicità non nasce solo dall’estetica o dalla riconoscibilità, ma dalla capacità di generare impatto sociale: “Brand come Patagonia, Ben & Jerry’s o Lacoste hanno costruito la loro identità attorno a cause condivise, trasformando il consumo in partecipazione.”
In BPER questa visione prende forma nei progetti che mettono al centro le persone e i territori: dalle sponsorizzazioni culturali e sportive al progetto GRANDE! per l’educazione finanziaria dei bambini, dai webinar Oltre il Rosa all’iniziativa La Galleria BPER, che rende accessibile una delle più importanti corporate collection italiane. “È così che il brand evolve – conclude Bianchi – da marchio commerciale a presenza sociale attiva, riconoscibile e significativa.”
Una prospettiva diversa ma complementare è quella di Chiara Aluffi Pentini (UNICEF), per cui “non siamo un semplice marchio commerciale, ma un simbolo che rappresenta l’importanza di guardare il bambino come soggetto titolare di diritti”. Nei Paesi ad alto reddito, come l’Italia, il brand si manifesta attraverso le iniziative “amiche dei bambini”: scuole, città, biblioteche e musei che diventano spazi di educazione e consapevolezza. “Gettiamo nell’arena dei social e della TV quello che siamo, parlando della nostra missione con onestà e umanità vera, senza artifici comunicativi. Un brand Pop deve essere parte della vita delle persone come compagno, non come interruzione.”
Nel mondo B2B, Filippo Bertacchini (BASF) sottolinea che “un brand diventa iconico quando riesce a combinare estetica, emozione e significato in modo coerente e memorabile”. Ma in un contesto industriale “occorre chiedersi: per chi voglio essere un simbolo culturale? Anche un’azienda tecnica può lavorare su asset come sostenibilità, inclusione e impegno sociale, diventando simbolo all’interno del proprio mercato.”
Per Alberto Federici (Unipol), invece, la trasformazione culturale deve partire dalla consapevolezza della propria identità: “Un’azienda assicurativa deve darsi una spolverata all’abito blu che indossa, ma non deve mettersi in maglietta e bermuda.” La sfida è “parlare il linguaggio dell’uomo della strada e dei giovani, senza rinunciare a sicurezza e affidabilità”. Un equilibrio fra solidità e apertura che rende credibile il marchio anche in un contesto pop.
“Oggi, commenta Max Tanganelli (Bip Red) nello stesso momento, un’azienda può trovarsi a scegliere se investire sulla TV tradizionale, su Netflix o su TikTok: tre linguaggi completamente diversi che fanno, in modi opposti, la stessa cosa: intrattenimento. E questa è solo una piccola parte della costellazione di formati che definiscono il mondo contemporaneo dei media. In questo contesto, la vera sfida non è più “dove” comunicare, ma come abitare la cultura. Un brand diventa un simbolo culturale quando smette di parlare solo di sé e inizia a partecipare a una conversazione sociale, portando un punto di vista sul mondo, non solo sul mercato. Non basta presidiare i media: serve costruire senso, prospettiva, linguaggio. Per questo, prima ancora di scegliere un canale o un format, un brand dovrebbe chiedersi che tipo di racconto vuole costruire e quale mezzo è davvero in grado di amplificarlo con coerenza e profondità. Non tutti i brand devono fare un podcast, aprire un canale su TikTok o rincorrere il trend del momento: ogni scelta dovrebbe partire dall’identità narrativa del brand, non dall’hype. Saper scegliere il mezzo giusto significa saper tradurre la propria storia in un’esperienza culturale riconoscibile, capace di generare valore per chi la riceve. Così un brand smette di essere un semplice logo commerciale e diventa una voce nel coro della cultura contemporanea. In fondo, si tratta di costruire un linguaggio che invita, coinvolge e chiama dentro una visione condivisa. Solo così il brand può davvero trasformarsi in un simbolo culturale vivo, generativo e necessario”.
- Dalla forza vendita al curatore di cultura
In un tempo in cui ogni interazione può diventare relazione, la forza vendita è il primo presidio culturale del brand. “Un linguaggio convocativo – osserva Bianchi – è un linguaggio che invita a partecipare, che crea spazio per il dialogo e la co-creazione.” In BPER questo approccio si traduce in una comunicazione “aperta”, capace di adattarsi ai contesti e ai canali: dai post social ai webinar fino ai materiali formativi, ogni punto di contatto è progettato per essere rilevante, empatico e coerente. “Le persone di BPER – aggiunge – diventano facilitatori di relazione, capaci di trasformare ogni interazione in un momento di Collaborazione Pop, dove il cliente si sente parte di un percorso condiviso.”
Anche nel settore assicurativo la parola chiave è vicinanza. “La forza vendita va aiutata a essere più chiara, esaustiva, accogliente – afferma Federici. L’assicurazione soffre di complessità e linguaggio burocratico, e deve fare uno sforzo maggiore per creare sintonia. Un po’ di linguaggio pop non guasterebbe.” Per Unipol, la modernizzazione passa dal ricambio generazionale degli agenti e dall’apertura al canale digitale, “che crea maggiore prossimità nella relazione”.
Osserva Tanganelli: “La forza vendita resta un punto di contatto fondamentale tra brand e audience, e abbiamo esempi virtuosi di aziende che hanno spostato significativamente il focus della comunicazione sulle dinamiche di interazione, mettendo al centro questo asset di brand e lavorando su linguaggi alternativi che aggiungono nuove sfumature al tono di voce del brand stesso. In questo contesto, il trasferimento dei valori e delle modalità comunicative dal brand alla forza vendita diventa essenziale per non disperdere il percepito. Questo processo passa attraverso diversi snodi come la capacità attrattiva del brand di richiamare talenti che possano diventare ambassador, la costruzione di un impianto narrativo forte, facilmente assimilabile e condivisibile e la messa a disposizione di strumenti utili per raccontare prodotti o servizi, integrando dinamiche di ingaggio che creino prossimità tra l’espressione del brand e le persone che ne diventano divulgatori. In questa prospettiva, l’uso dell’AI come abilitatore di conversazioni può potenziare questa connessione, rendendo il racconto più coerente e personalizzato. Gli strumenti di identità di brand destinati agli employee devono evolvere: meno “per addetti ai lavori” e più accessibili, capaci di tradurre in modo semplice e autentico il modo in cui il brand costruisce relazione. Così, anche questo livello di interazione, pur delegato, può essere indirizzato e valorizzato, diventando un ulteriore canale per avvicinare il brand alle audience e trasformare ogni incontro in un momento di autentica Collaborazione Pop”.
Per Aluffi Pentini, la prospettiva è ancora diversa: UNICEF non ha una forza vendita in senso stretto, ma “centinaia di volontari e dialogatori che ogni giorno parlano dell’organizzazione”. La formazione e la condivisione delle esperienze rendono queste interazioni “spontanee e genuinamente personalizzate”. L’esperienza della donazione stessa diventa trasformativa, come dimostra il progetto Paddington, nato da un processo di design thinking con i genitori per creare un’esperienza condivisa tra adulti e bambini.
Bertacchini aggiunge che, anche nei settori tecnici, la formazione può trasformare i venditori in ambasciatori culturali del brand: “Customer centricity e self branding sono strumenti potenti. Ogni venditore può incarnare i valori dell’azienda e raccontarli in modo autentico. Anche dove prevale la razionalità, le storie di collaborazione reale creano senso collettivo.”
- Il brand come mentalità fluida
“Negli ultimi anni, sostiene Tanganelli, il rapporto tra brand e audience si è evoluto da un modello one-to-many a uno many-to-many, spostando al di fuori del controllo diretto dei brand molte delle conversazioni che ne influenzano la reputazione. Basti pensare a come oggi le persone scelgano prodotti o servizi in base ai commenti su Amazon o ai thread su Reddit: piattaforme che amplificano le conversazioni, restituiscono potere alle audience e ridefiniscono i concetti di storytelling di marca.
In questo scenario, i brand non possono più entrare in queste community imponendo messaggi, ma devono osservare, ascoltare e imparare, trasformando le conversazioni in insight per evolvere prodotti e servizi. Parallelamente, devono rafforzare la propria identità per poter orientare in modo credibile queste conversazioni. Diventare fluidi significa saper veicolare messaggi coerenti verso audience diverse, per età, valori o modalità di fruizione, mantenendo un nucleo valoriale stabile ma declinabile. Questa fluidità consente di entrare davvero in contatto con le persone, avvicinarsi e farsi percepire come vicini e rilevanti. In questo senso, la narrazione dell’heritage di brand, la storia, le origini, i valori fondativi, va riraccontata in chiave contemporanea, rompendo i confini della comunicazione istituzionale. Il valore di un brand non risiede più solo nella dimostrazione di grandezza, solidità o audacia, ma nella capacità di rendere la propria storia condivisibile ed empatica, trasformandola in una piattaforma narrativa aperta alla co-creazione”.
Un brand oggi non è più un’identità rigida ma un sistema aperto, un linguaggio che si rigenera costantemente. “La costruzione del brand è un processo fluido – afferma Bianchi – che si alimenta di esperienze, riletture e partecipazione.” Il retelling di storie già note permette di reinterpretare il proprio patrimonio con linguaggi nuovi, come avviene nei podcast The Real Genius o nell’ecosistema B-education, che trasforma l’educazione finanziaria in narrazione partecipativa. “Ogni contenuto è una porta aperta sul significato profondo dell’identità aziendale.”
Aluffi Pentini sottolinea che “fluidità vuol dire passare dai temi delle emergenze a quelli di sviluppo, mantenendo credibilità e coerenza”. La sfida per UNICEF è ampliare il mandato verso adolescenti, salute mentale e partecipazione, restando fedele alla propria missione. “Abbiamo un’awareness fortissima su alcuni temi, ma meno su altri: il nostro ecosistema narrativo deve essere modulare, capace di adattarsi.” Anche il retelling del passato ha un ruolo cruciale: “Raccontare i tempi in cui UNICEF portava latte e scarpe ai bambini italiani nel dopoguerra crea la fiducia necessaria per parlare oggi di lasciti e futuro.”
Federici riconosce una difficoltà analoga: “Le assicurazioni soffrono dell’incapacità di raccontare a cosa servono e come funzionano.” Il superamento di questa distanza passa per un linguaggio nuovo, empatico e comprensibile, ma anche per iniziative concrete “che mettano le compagnie in mezzo alle persone, non sopra di loro”.
Bertacchini sintetizza il concetto in chiave metodologica: “Una mentalità fluida implica che il brand non è più un’entità statica, ma un sistema adattivo capace di evolvere con il contesto culturale e sociale. Il retelling non è ripetizione, ma reinterpretazione che genera nuovi significati.”
- L’AI e il ritorno dell’umano
Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, la differenza la fa chi sa dare senso. “Il vero elemento distintivo resta il fattore umano – osserva Bianchi. L’AI può semplificare, ma è la persona che dà orientamento e valore.” In BPER l’intelligenza artificiale è usata per potenziare l’empatia, non per sostituirla: “Abbiamo sviluppato agenti conversazionali che interpretano i comportamenti digitali, ma sempre con l’obiettivo di amplificare le capacità umane, non rimpiazzarle.”
Bertacchini concorda: “Il vantaggio competitivo resta umano: intuizione, empatia e relazioni contano più degli algoritmi.” L’essere umano deve restare regista della creatività, non spettatore. “Usiamo l’AI per amplificare, non sostituire, e per valorizzare punti di vista autentici.”
Federici ne offre una visione concreta e prudente: “Un tool di AI che sostituisca in tutto e per tutto l’uomo non l’abbiamo trovato. Pensavamo avrebbe permesso di fare più cose in meno tempo, ma la realtà è più complessa. Ci arriveremo, ma servono regole, e siamo ancora in tempo per scriverle.”
Per Aluffi Pentini, infine, la questione è anche etica: “I contenuti AI sono verosimili ma non veri. Nel nostro lavoro con i bambini ci siamo dati limiti stringenti sull’uso delle immagini: la fiducia dei donatori non può essere mediata da un algoritmo.” L’AI, per UNICEF, resta un potente strumento di efficienza e analisi, ma “la relazione umana rimane insostituibile”.
Conclude Tanganelli: “L’hype crescente verso l’AI generativa sta spingendo le aziende a investire in tecnologie che semplificano la produzione dei contenuti, liberando tempo e risorse da dedicare ad attività a maggiore valore percepito. Nonostante i progressi rapidissimi e la qualità sempre più alta degli output, l’AI è oggi percepita come supporto, non come guida alla produzione creativa. In questo contesto, lo human in the loop, il valore dell’esperienza umana che orienta, integra ed eleva l’intelligenza artificiale, diventa essenziale per creare un percepito distintivo intorno ai brand. Le modalità di progettazione della comunicazione si stanno ridefinendo: l’AI supporta il processo, ma il vero valore generativo resta nella creatività umana. Questa commistione tra intelligenza emotiva e produzione automatizzata impone di ripensare come integrare l’AI non più solo come strumento di efficienza, ma come amplificatore dell’esperienza e ridefinizione dell’identità di brand. Pensiamo, per esempio, a come cambierà il Tone of Voice quando un’AI dialogherà direttamente con la nostra audience, dovrà trasmettere valori e sensibilità coerenti con l’identità del brand. Allo stesso modo, se una decisione d’acquisto passerà da un’interazione con un assistente AI come GPT, i brand dovranno ripensare la propria narrativa per essere riconoscibili anche all’interno delle risposte delle macchine”.
- Followership consapevole e curatela del senso
Oltre la semplice differenziazione di prodotto, la nuova frontiera è la costruzione di una followership consapevole. “La differenziazione oggi nasce dalla capacità del brand di generare feeling – spiega Bianchi –: un legame autentico basato sulla fiducia e sulla condivisione.” I progetti educativi e sociali, come GRANDE! o Oltre il Rosa, incarnano questa visione, “trasformando la banca in uno spazio che forma cittadini consapevoli, non solo clienti”.
Federici riflette sullo stesso tema in chiave emozionale: “Uno dei pericoli è pensare che basti comunicare quanto è bello un prodotto. Ma se non comunichi ciò che sei tu, dentro quel prodotto, la comunicazione resta arida. Serve un’anima anche nella comunicazione di prodotto: bisogna parlare al cuore, non solo alla testa.”
Per Aluffi Pentini, la generazione di senso è la ragione stessa d’essere del brand: “Non chiediamo, proponiamo di fare un pezzo di strada insieme. Passiamo da una logica di ask a una logica di offer, per costruire valore condiviso con i nostri partner.” È una forma di curatela che richiede ascolto e capacità di mediazione culturale.
“La consapevolezza delle audience è ormai un tema centrale, conferma Tanganelli, presente da anni tra i principali trend della comunicazione. Le persone scelgono un brand, come consumatori o come potenziali dipendenti, se si sentono vicine ai suoi valori, se ne condividono le posizioni, le scelte e le azioni, oltre che i benefici concreti. Questa esigenza di autenticità non può più essere semplicemente assecondata: il rischio di essere percepiti come poco trasparenti o “costruiti” può compromettere la credibilità del brand. Per questo, le aziende devono superare lo storytelling inteso come narrazione artificiale e abbracciare il truthtelling, ovvero la capacità di raccontarsi in modo spontaneo, autentico e coerente, creando una narrazione di valore reale e condivisa. Il truthtelling non serve solo ad attrarre chi condivide gli stessi ideali, ma diventa un mezzo per generare consapevolezza sulle scelte del brand, dai processi di produzione alla responsabilità sociale, per portare valore tangibile alla società. I brand devono riconoscere e accogliere la responsabilità che deriva dal loro ruolo culturale: non più portatori di valori solo per sé stessi, ma per una comunità di persone che si riconosce e si sente rappresentata in essi”.
Bertacchini chiude il cerchio: “La followership consapevole è fatta di connessione, feedback, trasparenza e pensiero critico. Non è obbedienza, ma partecipazione attiva. Il follower diventa parte della visione, e questo rafforza il brand più di qualsiasi leadership carismatica.”
Comunicare per farsi ricordare
Da Unipol a UNICEF, da BPER a BASF, passando per Bip Red, emerge un filo rosso: il brand è una forma di appartenenza che si costruisce nella relazione, nell’empatia e nella responsabilità. La Pop Communication non è un’operazione estetica, ma una sfida culturale: riportare l’impresa dentro la società, e la società dentro l’impresa.
Puntate precedenti