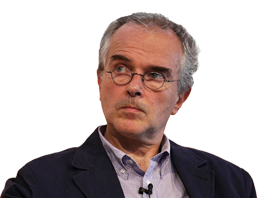L’urgenza di una nuova consapevolezza
Secondo il report che CB Insights ha appena pubblicato sul futuro dei servizi professionali nell’era dell’intelligenza artificiale agentiva (The Future of Professional Services – How firms will capture value in the AI agent era) siamo di fronte a una svolta epocale nel modo in cui le organizzazioni creano e distribuiscono valore. Le società di consulenza, da sempre custodi del sapere strategico e operativo, stanno vivendo di conseguenza una trasformazione che le costringe a passare dall’advisory classico alla realizzazione orchestrata tramite AI agent.
Si tratta di capire come l’intelligenza artificiale viene orchestrata, integrata, resa parte di un sistema più ampio che include dati proprietari, piattaforme riusabili e, soprattutto, workforce miste, dove umani e AI collaborano in modi ancora da indagare compiutamente.
Ora, poichè, come dicevamo ad esempio in Prolegomeni 134 “il Pop Management fa dell’azienda un ecosistema vivente, una comunità interconnessa dove energia e creatività fluiscono liberamente”, questo Prolegomeno nasce con un obiettivo preciso: tradurre le evidenze empiriche raccolte da CB Insights in principi operativi applicabili alla cornice teorico-pratica del Pop Management. Si tratta di verificare quali indicazioni siano genuinamente “traslabili” nel nostro approccio, quali richiedano una rielaborazione critica e quali invece vadano integrate con dimensioni che il report, pur nella sua solidità analitica, non può cogliere pienamente. La dimensione emotiva e relazionale non è un optional ma un prerequisito per qualsiasi trasformazione tecnologica che voglia essere sostenibile nel tempo.
La domanda chiave delle organizzazioni moderne
Le società di consulenza si trovano oggi ad affrontare una domanda che suona quasi esistenziale: cosa accade al modello di business tradizionale quando i clienti hanno accesso diretto all’expertise potenziata dall’intelligenza artificiale? I grandi network globali hanno già dispiegato migliaia di agenti AI internamente per supportare i propri professionisti e rendere più snelli i team di progetto. Alcune organizzazioni hanno annunciato la fusione di intere unità operative in nuove business line dedicate esclusivamente ad aiutare i clienti a rivoluzionare le proprie operazioni attraverso l’AI.
La direzione è chiara, anche se il percorso rimane ancora da definire nei dettagli: le organizzazioni che riusciranno a passare dall’offrire consulenza al costruire e orchestrare sistemi AI complessi saranno quelle che plasmeranno il futuro dell’economia basata sull’intelligenza artificiale. Ma questa transizione solleva questioni profonde che vanno ben oltre la mera implementazione tecnologica. Riguardano il modo in cui concepiamo il lavoro, il valore della conoscenza umana, la natura della collaborazione, e soprattutto il ruolo della governance in sistemi sempre più autonomi.
Vorrei richiamare qui quanto avevo osservato sul tema della predizione come nuova forma di attività, a margine di una nota di Cosimo Accoto (Mezzi di predizione come nuovi mezzi di activity). La predizione smette di essere solo “forecast” e diventa infrastruttura dell’operatività: segnali anticipatori ridefiniscono priorità, sequenze e responsabilità dei team. Gli AI agent non si limitano a prevedere, ma ri-organizzano l’azione: (1) introducendo metriche anticipative accanto a quelle consuntive, (2) abilitando orchestrazione adattiva in tempo reale (routing, escalation), (3) richiedendo governance di pre-commitment su quali decisioni si automatizzano e quali restano sotto supervisione umana.
Orchestrare lo stack: la disciplina che mancava
Il primo punto evidenziato dal report CB Insights riguarda dunque l’orchestrazione dello stack (l’insieme) di AI agent. Molte iniziative ambiziose rimangono intrappolate in fase pilota, non per mancanza di tecnologia o di visione, ma a causa della complessità di integrazione, dei problemi di sicurezza e di quella che il report chiama efficacemente “vendor sprawl” – la proliferazione incontrollata di fornitori che porta le organizzazioni ad accumulare decine di soluzioni specializzate acquistate in modo non coordinato, creando arcipelaghi tecnologici isolati dove ogni strumento ha le proprie API proprietarie, formati dati e interfacce difficili da integrare.
Ma qui dobbiamo fermarci un momento e interrogarci: l’orchestrazione è davvero solo una questione di piattaforme tecnologiche? La risposta del Pop Management è netta: no. L’orchestrazione è prima di tutto una disciplina manageriale che coinvolge processi, ruoli, interfacce, metriche e meccanismi di audit. Quando parliamo di orchestrare sistemi di AI agent, non stiamo semplicemente collegando API e gestendo flussi di dati. Stiamo progettando sistemi socio-tecnici complessi dove le decisioni tecniche hanno immediate ricadute organizzative, e viceversa.
Servono quindi standard minimi condivisi che vadano ben oltre le specifiche tecniche: policy chiare sui dati, procedure di escalation quando gli agent incontrano situazioni ambigue, meccanismi di controllo umano che non siano semplici “pulsanti rossi” da premere in caso di emergenza ma veri e propri sistemi di supervisione integrata, oltre a pratiche di versioning degli agent che permettano di tracciare l’evoluzione delle loro capacità e dei loro limiti. Ogni iniziativa deve lasciare artefatti riusabili: non solo codice, ma schede documentate di ogni agent che specifichino scopo, limiti, fonti di dati, modalità di intervento umano, pipeline di sviluppo complete e verificabili, log che consentano audit retrospettivi.
Il Pop Manager, in questo contesto, emerge come figura dell’orchestratore pragmatico. Non è né il tecnologo puro che si preoccupa solo dell’efficienza computazionale, né il manager tradizionale che delega l’implementazione senza comprenderne le implicazioni. È invece colui che collega strategia e operatività, integra i saperi distribuiti nella community di pratica, misura risultati concreti senza cadere nell’esibizionismo metrico che ha afflitto tante iniziative di digital transformation. Sa che l’orchestrazione non è solo collegare componenti, ma creare le condizioni perché umani e agent possano effettivamente collaborare in modo produttivo e sostenibile. Stefano Bottaro – HR Director, Avio in Prolegomeni 128 afferma: “La leadership orizzontale, per sua natura, valorizza il contributo di tutti e la costruzione del consenso, il che può rallentare i processi decisionali. In una crisi, però, il tempo è un lusso che non ci si può permettere». Ricordandoci che progettare l’orchestrazione significa anche definire chi decide cosa e in che tempi.
I dati come bene comune e leva strategica
Il secondo pilastro identificato da CB Insights riguarda l’attivazione dei dati proprietari come leva di differenziazione. Gli agent creano valore autentico quando sono ancorati a dati contestuali di alta qualità: qui le società di consulenza possiedono un vantaggio competitivo significativo ma sottoutilizzato. Come osserva un dirigente intervistato nel report, queste organizzazioni hanno osservato processi backend in migliaia di aziende diverse, acquisendo una visibilità trasversale che nessuna singola impresa può avere sui propri processi interni. Nascono quindi data layer dedicati, strategie di data fabric, sistemi di retrieval sofisticati, policy di consenso e ‘moat’ verticali (vantaggi competitivi difendibili) in domini regolati, dove la profondità di specializzazione settoriale e la qualità dei dati proprietari creano barriere difficili da replicare per i competitor.
Ma anche qui la prospettiva del Pop Management introduce una torsione critica rispetto alla narrativa puramente strategico-competitiva. I dati vanno trattati come bene comune d’impresa, non come asset proprietario da blindare. Questo non significa ingenua apertura indiscriminata, ma richiede contratti d’uso chiari, misurazione continua della qualità, garanzie di portabilità. Quando i deliverable di un progetto diventano memorie operative che alimentano la base di conoscenza e gli agent futuri, stiamo implicitamente costruendo un nuovo tipo di organizzazione che apprende in modo distribuito e cumulativo.
Le mappe di consenso e i diritti di accesso devono essere espliciti, revisionabili, etici. Non basta dire “abbiamo i dati”. Bisogna poter rispondere a domande come: chi ha acconsentito a cosa? Con quale livello di granularità? Per quanto tempo? Con quali diritti di revoca? Questi non sono dettagli burocratici ma questioni fondamentali di governance che determinano se un sistema di AI agent può operare in modo trusted o se è destinato a generare resistenze e conflitti.
Il rischio da evitare è quello della black box proprietaria che tanto ha caratterizzato la prima ondata di digitalizzazione aziendale. Il Pop Management promuove invece prodotti aperti, interoperabili, co-creati con clienti, partner e ricercatori, alimentando un ciclo di apprendimento pubblico attraverso blog, discussioni su LinkedIn, ebook condivisi, repository accessibili. La conoscenza non è proprietà, è flusso. E i dati, in questa prospettiva, sono nodi di un flusso che deve rimanere vitale, non stagnare in silos competitivi. Si applica cioè anche in questo caso quanto dicevo in Prolegomeni 131: “Il Pop Management concepisce l’impresa come una narrazione co-creata, dove ogni individuo contribuisce attivamente alla storia dell’organizzazione, a fare evolvere l’impresa in un ambiente dove la collaborazione, l’innovazione e il coinvolgimento sono alimentati dalla condivisione metadisciplinare di competenze ed esperienze”.
Dalla consulenza al prodotto (aperto): una trasformazione economica
Il terzo asse strategico riguarda il passaggio da progetti personalizzati a piattaforme riusabili. CB Insights documenta la crescita di modelli “service-as-software”, con piattaforme specifiche per industry, sperimentazione di pricing innovativi che includono abbonamenti e modelli outcome-based e investimenti massicci in startup che stanno aggiornando il toolkit fondamentale del consulente. Le società non si limitano più a consigliare quale tecnologia adottare, ma costruiscono esse stesse le fondamenta platform-based su cui poi configurare rapidamente soluzioni per contesti specifici.
Questa evoluzione ha implicazioni economiche profonde. Quando le organizzazioni ridisegnano workflow attraverso AI generativa per migliorare efficienza, aumentare crescita dei ricavi e generare risparmi sui costi, tutto legato a pricing basato sulla performance effettiva, non stiamo più parlando del modello a ore/uomo che ha dominato la consulenza per decenni. Stiamo entrando in un territorio dove il valore viene catturato in base all’impatto misurabile, con tutte le complessità e le opportunità che questo comporta.
Il Pop Management abbraccia questa direzione ma con cautela critica. Nella Conversazione Collaborativa contenuta in Prolegomeni 124, ad esempio, si ribadisce che attivare l’intelligenza collaborativa vuol dire rendere il brand patrimonio condiviso, capace di essere usato e reinterpretato dalla comunità. L’apertura non è un vezzo: è la condizione per adottare e adattare piattaforme in ecosistemi reali.
In questo contesto significa che ogni progetto deve lasciare un asset – modulo, libreria, agente, playbook o dataset – con licenze e API chiaramente definite. Il catalogo interno di componenti riusabili diventa infrastruttura strategica, ma deve essere accompagnato da criteri espliciti di qualità, piani di manutenzione, procedure per il ritiro controllato di funzionalità obsolete. Non basta accumulare componenti: serve curare un ecosistema vivente di artefatti software e metodologici.
Il pricing legato all’impatto ottenuto reale è attraente ma solleva questioni etiche non banali. Quando è davvero misurabile? Chi definisce le metriche? Come si gestiscono gli effetti collaterali non previsti? Le salvaguardie etiche e di sicurezza non possono essere negoziabili, anche quando renderebbero un accordo economicamente più vantaggioso. Soprattutto, la logica della ricerca-azione aperta implica che ogni release comporta una documentazione pubblica: articolo, thread di discussione, appendice in ebook che racconti non solo i successi ma anche gli errori, le correzioni, i miglioramenti iterativi. Questo tipo di trasparenza è rara nel mondo della consulenza tradizionale, ma è essenziale per costruire fiducia e permettere apprendimento collettivo.
La workforce del futuro: umani e AI insieme
Il quarto pilastro identificato da CB Insights riguarda la costruzione della workforce umano-AI. Qui tocchiamo forse il punto più delicato dell’intera trasformazione. La piramide tradizionale che ha strutturato le società di consulenza per generazioni si sta assottigliando alla base. Meno task ripetitivi affidati ai junior, più richiesta di profili senior-specialist e di una nuova figura professionale: l’agent manager. Crescono gli investimenti in reskilling e si diffondono approcci “client zero”, dove le società testano internamente le soluzioni prima di proporle ai clienti, trasformando i propri dipendenti in primi utilizzatori e validatori.
I lavoratori stanno diventando, nelle parole del report, “agentic product owners” che orchestrano sistemi AI anziché eseguire task direttamente. Il ruolo umano si sposta verso supervisione, validazione, direzione strategica. Le organizzazioni leader stanno dispiegando centinaia di agenti a decine di migliaia di dipendenti, focalizzandosi su aree come compliance fiscale, risk management, analisi finanziaria. Altre hanno formato centinaia di migliaia di dipendenti all’uso dell’AI generativa e hanno acquisito piattaforme di e-learning per lanciare servizi dedicati all’upskilling dei propri clienti.
Ma cosa significa tutto questo per le persone reali che lavorano in queste organizzazioni? Il Pop Management rifiuta la retorica semplicistica dell’AI che “libera gli umani dai compiti noiosi per concentrarsi su attività creative”. La realtà è più complessa e richiede attenzione ai dettagli organizzativi e alle dimensioni emotive del cambiamento. Servono team misti con ruoli nuovi: non solo strategist e domain expert tradizionali, ma agent orchestrator che gestiscono sistemi multi-agente, data steward che curano la qualità e l’etica dei dati, ethics and safety lead che vigilano su bias e impatti non intenzionali.
L’AI-fluency deve diventare competenza diffusa, non limitata a una elite tecnica. Questo richiede percorsi pratici di apprendimento, mentoring tra pari, comunità interne di pratica dove chi ha più esperienza aiuta chi sta iniziando. I KPI devono includere non solo metriche di efficienza ma anche di qualità dell’output, affidabilità dei sistemi, e soprattutto impatto umano: livelli di adozione effettiva, carico cognitivo percepito, benessere del team. Una tecnologia che aumenta la produttività ma devasta il morale e la salute mentale dei lavoratori non è un successo, è un fallimento mascherato da metriche parziali.
Perché proprio adesso: il momento del consolidamento
CB Insights osserva che l’ecosistema si sta consolidando in reti many-to-many tra big tech, sviluppatori di LLM, fornitori di enterprise software e piattaforme MLOps. I colli di bottiglia ricorrenti che emergono dalle interviste e dai dati sono sostanzialmente due: orchestrazione e fiducia. Chi riesce a risolvere questi due nodi costruisce un vantaggio competitivo che non dipende dal “modello del momento” – oggi GPT-4, domani Claude 4, dopodomani qualcos’altro – ma da processi solidi, dati curati, governance trasparente.
Questo è il motivo per cui il momento attuale è così rilevante. Non stiamo assistendo all’ennesimo hype tecnologico destinato a sgonfiarsi, ma a una riorganizzazione strutturale del modo in cui le organizzazioni operano. Le società che stanno investendo miliardi in piattaforme di orchestrazione, acquisizioni strategiche di startup, reskilling massiccio della forza lavoro, non lo fanno per moda ma perché hanno compreso che chi ritarda sarà superato da competitor più agili, e soprattutto da nuovi entranti che nascono già con DNA AI-native. Tuttavia, la tecnologia sottostante—a partire dai modelli—conta molto meno di quanto pensiamo. Le ‘classifiche’ cambiano di continuo: ciò che oggi è primo domani è terzo, non perché sia peggiorato, ma perché altri hanno rilasciato aggiornamenti. Questo dice una cosa chiara: siamo entrati in un’era di parità approssimativa tra i modelli all’avanguardia. Le differenze esistono, ma sono minime e temporanee. L’AI in sé si sta commoditizzando. Quello che conta ora è tutto ciò che le ruota attorno: dati proprietari, orchestrazione multi-agent, governance, processi, ruoli e metriche condivise. È qui che si costruisce il vantaggio competitivo.
Una lettura critica dal punto di vista del Pop Management
A questo punto è necessario rileggere criticamente quanto emerso dal report CB Insights attraverso le lenti specifiche del Pop Management, evidenziando convergenze ma anche punti di tensione produttiva.
Primo: il passaggio dal sapere al fare misurabile. La trasformazione del sapere consulenziale in capacità esecutiva scalabile è certamente la direzione corretta. Ma deve rimanere aperta, verificabile, continuamente migliorabile. Il rischio è che la trasformazione dei servizi in prodotti diventi una scusa per cristallizzare conoscenza in formati proprietari e black-box, quando invece l’obiettivo dovrebbe essere creare commons aperti e interoperabili.
Secondo: l’Intelligenza Collaborativa come architettura fondamentale. Il report documenta bene che non vince il singolo modello AI più potente, ma vince l’integrazione efficace di competenze umane, dati curati, agent ben orchestrati, persone motivate, piattaforme robuste. Qui si innestano perfettamente le tre dimensioni che, integrate nel quadro valoriale del Pop Management, definiscono l’Intellligenza Collaborativa: l’intelligenza collettiva teorizzata da Pierre Lévy, dove il sapere è distribuito ovunque e va costantemente valorizzato; l’intelligenza connettiva di Derrick de Kerckhove, che sottolinea come le reti tecnologiche non sostituiscano ma amplifichino le reti di significato umane; e l’intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che ci ricorda come nessuna orchestrazione tecnicamente perfetta possa reggere nel tempo senza fiducia reciproca, attenzione al contesto relazionale, cura delle dinamiche emotive dei team.
Terzo: la governance come pratica culturale quotidiana, non come insieme di controlli formali applicati ex post. Il report menziona giustamente l’importanza di governance e trust, ma tende a trattarli come layer tecnico-procedurale. Il Pop Management insiste invece sulla necessità di trasparenza radicale delle decisioni (perché questo agent è stato configurato così? quali alternative sono state scartate e perché?), accountability chiara (chi risponde di cosa quando un agent produce risultati problematici?), tutela effettiva dei diritti dei lavoratori (possono opporsi a decisioni degli agent? con quali meccanismi?), e coinvolgimento diffuso nella definizione stessa dei KPI (non calati dall’alto ma negoziati con chi poi dovrà viverli quotidianamente).
Ogni agent dovrebbe avere una scheda di trasparenza che specifichi: quali fonti dati utilizza, quali sono i suoi limiti dichiarati, quali metriche vengono monitorate, quali meccanismi di controllo umano sono previsti, come funziona l’audit trail. Questo non è un vezzo burocratico ma un requisito essenziale per costruire sistemi in cui le persone possano riporre fiducia giustificata.
Quarto: asset riusabili ma senza chiusura Abbiamo già accennato a questo punto, ma merita un’ulteriore elaborazione. Il Pop Management promuove un modello dove i prodotti – siano essi agent, piattaforme, dataset, metodologie – rimangono aperti e interoperabili per scelta strategica, non per obbligo esterno. Alimentano cicli di apprendimento pubblico dove successi e fallimenti vengono condivisi, discussi, migliorati collettivamente. La conoscenza organizzativa non è property da proteggere gelosamente ma flusso da mantenere vitale attraverso scambio continuo.
Dieci principi operativi per una nuova pratica manageriale
Da questa rilettura critica emergono dieci principi operativi che possono guidare concretamente l’azione dei Pop Manager nell’era dell’AI agentiva.
Il primo principio afferma che orchestrazione non equivale a somma di tool. Progettare sistemi dove AI agent operano efficacemente significa progettare sistemi socio-tecnici completi, con processi espliciti, ruoli definiti ma flessibili, policy condivise, interfacce curate, e soprattutto feedback loop che permettano apprendimento continuo. Non basta comprare le migliori piattaforme sul mercato: serve tessere una trama organizzativa che le sostenga.
Il secondo principio richiede di trattare i dati come bene comune d’impresa. Questo implica costruire data layer condivisi dove qualità e consenso sono tracciabili in ogni momento, e dove i deliverable di progetti diventano automaticamente memorie operative che arricchiscono la base di conoscenza collettiva. Non più documenti che finiscono dimenticati in qualche repository, ma componenti vivi di un sistema che apprende.
Il terzo principio promuove un modello di service-as-software aperto, dove ogni progetto rilascia asset riusabili con licenze chiare e API ben documentate. Il valore non sta nel tenere segreti i propri tool, ma nel dimostrare capacità superiori di orchestrazione e adattamento, capacità che non si copiano semplicemente scaricando codice.
Il quarto principio stabilisce che sperimentare un pricing basato su risultati misurabili è importante, ma non al prezzo di compromessi su valori fondamentali o di pressioni insostenibili su chi deve implementare le soluzioni.
Il quinto principio introduce il concetto di trust by design: ogni agent deve avere una scheda di trasparenza completa, comprensibile, aggiornata, che specifichi fonti dati, limiti noti, metriche monitorate, controlli umani previsti, meccanismi di audit. La trasparenza non è un lusso ma un requisito architetturale.
Il sesto principio definisce il Pop Manager come orchestratore pragmatico (Simposiarca) che collega strategia e operatività quotidiana, integra saperi distribuiti nella community di pratica, misura risultati concreti evitando sia l’assenza di metriche sia l’esibizionismo metrico fine a se stesso. È figura di mediazione tra logiche diverse, non di imposizione dall’alto.
Il settimo principio richiede upskilling continuo e aperto alla diversità, dove l’AI-fluency diventa competenza diffusa attraverso percorsi pratici, mentoring tra pari, comunità interne di pratica. I senior non sono “quelli che sanno” ma coach dell’orchestrazione, facilitatori dell’apprendimento collettivo.
L’ottavo principio promuove ecosistemi interoperabili basati su partnership many-to-many, approccio vendor-agnostic, portabilità dei dati e delle configurazioni, exit strategy chiare. Nessuna dipendenza strutturale da singoli fornitori, per quanto grandi o attraenti.
Il nono principio insiste su etica applicata e misurabile, non solo dichiarata. Servono indicatori concreti su bias nei sistemi, sicurezza delle operazioni, rispetto della privacy, impatto effettivo sul lavoro delle persone, benessere organizzativo. E servono meccanismi di intervento quando quegli indicatori segnalano problemi.
Il decimo principio istituisce la ricerca-azione aperta come modalità operativa standard: ogni release significativa comporta articolo pubblico, thread di discussione su LinkedIn, appendice in ebook con risultati ottenuti, errori commessi, correzioni applicate, miglioramenti previsti. L’apprendimento organizzativo diventa pubblico, contribuendo all’ecosistema più ampio.
La sfida culturale oltre quella tecnologica
In conclusione, il report CB Insights ci dice qualcosa di fondamentale: il futuro non appartiene a chi adotta più agent, ma a chi li orchestra meglio. Il Pop Management aggiunge una dimensione essenziale: l’orchestrazione è disciplina culturale prima ancora che tecnica. Richiede intelligenza collaborativa nelle sue tre dimensioni – collettiva, connettiva, emotiva. Richiede governance praticata quotidianamente come cultura organizzativa, non imposta episodicamente come compliance formale. Richiede una “platformizzazione dei servizi” che rimanga aperta e interoperabile per scelta strategica, non per concessione. Richiede workforce dove umani e AI si potenziano reciprocamente in modi che preservino e potenzino la dignità del lavoro umano, non che la erodano in nome dell’efficienza.
La posta in gioco non è l’efficienza fine a se stessa, parametro troppo spesso invocato per giustificare qualsiasi trasformazione. La posta in gioco è la capacità di generare valore sostenibile nel tempo, misurabile senza riduzionismi, condiviso equamente tra gli stakeholder, mantenendo sempre al centro le persone, i loro diritti inalienabili, il loro benessere concreto. Questo è ciò che rende il Pop Management non solo rilevante ma necessario in questo momento storico: offre una cornice teorico-pratica per navigare la trasformazione AI senza perdere di vista ciò che conta davvero.
Puntate precedenti
1 – DALLO HUMANISTIC AL POP MANAGEMENT
2 – MANIFESTI, ATLANTI, MAPPE E TERRITORI
3 – IL MANAGER PORTMANTEAU
4 – WHICH WAY, WHICH WAY?
5 – LEADERSHIP POP (LEZIONI SHAKESPEARIANE)
6 – OPINION PIECE DI RICCARDO MAGGIOLO
7 – LEADERSHIP POP (APERTURA, AUTONOMIA, AGIO, AUTO-ESPRESSIONE)
8 – OPINION PIECE DI JOSEPH SASSOON
9 – OPINION PIECE DI CESARE CATANIA
10 – OPINION PIECE DI VANNI CODELUPPI
11 – OPINION PIECE DI ALESSANDRO GIAUME
12 – COLLABORAZIONE POP. L’IRRESISTIBILE ASCESA DELLE COMMUNITY INTERNE
13 – COLLABORAZIONE POP. L’EMPATIA SISTEMICA
14 – COLLABORAZIONE POP. LE COMMUNITY AZIENDALI: UNO STATO DELL’ARTE, PARTE PRIMA
15 – COLLABORAZIONE POP. LE COMMUNITY AZIENDALI: UNO STATO DELL’ARTE, PARTE SECONDA
16 – OPINION PIECE DI MATTEO LUSIANI
17 – OPINION PIECE DI MARCO MILONE
18 – OPINION PIECE DI ALESSIO MAZZUCCO
19 – OPINION PIECE DI ALESSANDRA STRANGES
20 – OPINION PIECE DI FRANCESCO VARANINI
21 – ORGANIZZAZIONE POP. COMANDO, CONTROLLO, PAURA, DISORIENTAMENTO
22 – OPINION PIECE DI ROBERTO VERONESI
23 – OPINION PIECE DI FRANCESCO GORI
24 – OPINION PIECE DI NELLO BARILE
25 – OPINION PIECE DI LUCA MONACO
26 – OPINION PIECE DI RICCARDO MILANESI
27 – OPINION PIECE DI LUCA CAVALLINI
28 – OPINION PIECE DI ROBERTA PROFETA
29 – UN PUNTO NAVE
30 – ORGANIZZAZIONE POP. VERSO L’HYPERMEDIA PLATFIRM (CURA)
31 – OPINION PIECE DI NICHOLAS NAPOLITANO
32 – LEADERSHIP POP. VERSO L’YPERMEDIA PLATIFIRM (CONTENT CURATION)
33 – OPINION PIECE DI FRANCESCO TONIOLO
34 – ORGANIZZAZIONE POP. VERSO L’HYPERMEDIA PLATFIRM (CONVIVIALITA’)
35 – OPINION PIECE DI LUANA ZANELLATO
36 – OPINION PIECE DI ANDREA BENEDETTI E ISABELLA PACIFICO
37 – OPINION PIECE DI STEFANO TROILO
38 – OPINION PIECE DI DAVIDE GENTA
39 – OPINION PIECE DI ANNAMARIA GALLO
40 – INNOVAZIONE POP. ARIMINUM CIRCUS: IL READING!
41 – ORGANIZZAZIONE POP. VERSO L’HYPERMEDIA PLATFIRM (CONVOCAZIONE)
42 – OPINION PIECE DI EDOARDO MORELLI
43 – ORGANIZZAZIONE POP. VERSO L’HYPERMEDIA PLATFIRM (CO-CREAZIONE DI VALORE)
44 – OPINION PIECE DI MARIANNA PORCARO
45 – OPINION PIECE DI DONATO IACOVONE
46 – OPINION PIECE DI DENNIS TONON
47 – OPINION PIECE DI LAURA FACCHIN
48 – OPINION PIECE DI CARLO CUOMO
49 – OPINION PIECE DI CARLO MARIA PICOGNA
50 – OPINION PIECE DI ROBERTO RAZETO
51 – OPINION PIECE DI ALBERTO CHIAPPONI
52 – OPINION PIECE DI ALESSANDRO ANTONINI
53 – OPINION PIECE DI ALESSANDRA PILIA
54 – OPINION PIECE DI CLEMENTE PERRONE
55 – OPINION PIECE DI FABRIZIO RAUSO
56 – OPINION PIECE DI LORENZO TEDESCHI
57 – OPINION PIECE DI EUGENIO LANZETTA
58 – OPINION PIECE DI GIOLE GAMBARO
59 – OPINION PIECE DI DANTE LAUDISA
60 – OPINION PIECE DI GIAMPIERO MOIOLI
61 – OPINION PIECE DI GIOVANNI AMODEO
62 – OPINION PIECE DI ALESSANDRO LOTTO
63 – OPINION PIECE DI GIANLUCA BOTTINI
65– OPINION PIECE DI SIMONE FARINELLI
66– OPINION PIECE DI FRANCESCA ANNALISA PETRELLA
67– OPINION PIECE DI VALERIO FLAVIO GHIZZONI
68– OPINION PIECE DI STEFANO MAGNI
69– OPINION PIECE DI LUCA LA BARBERA
70 – INNOVAZIONE POP. ARIMINUM CIRCUS: LA GRAPHIC NOVEL!
71 – LEADERSHIP POP. APOFATICA E CATAFATICA DELLA COMUNICAZIONE
72 – OPINION PIECE DI FEDERICA CRUDELI
73– OPINION PIECE DI MELANIA TESTI
74 – OPINION PIECE DI GIANMARCO GOVONI
75– OPINION PIECE DI MARIACHIARA TIRINZONI
76 – SENSEMAKING POP. LODE DELLA CATTIVA CONSIDERAZIONE DI SE’
77 – OPINION PIECE DI ALESSANDRA CAPPELLO E ALESSANDRA MAZZEI
78 – OPINION PIECE DI JOE CASINI
79 – OPINION PIECE DI MARTA CIOFFI
80 – STORYTELLING POP. VERSO IL POP BRANDING (PARTE PRIMA)
81 – STORYTELLING POP. VERSO IL POP BRANDING (PARTE SECONDA)
82 – STORYTELLING POP. VERSO IL POP BRANDING (NOTE A MARGINE)
83 – ENGAGEMENT POP. IL MANAGER INGAGGIANTE IMPARA DAI POKEMON
84 – ENGAGEMENT POP. DARE VOCE IN CAPITOLO
85 – ENGAGEMENT POP. COMUNICARE, VALUTARE, TRASFORMARE
86 – SENSEMAKING POP. MALATTIA MENTALE E BENESSERE PSICOLOGICO SUL LAVORO
87 – SENSEMAKING POP. FOLLIA O DIVERSITA’?
88 – OPINION PIECE DI LUIGIA TAURO
89 – OPINION PIECE DI NILO MISURACA
90 – OPINION PIECE DI FRANCESCO DE SANTIS
91 – INNOVAZIONE POP. REMIX, RI-USO, RETELLING
92 – STORYTELLING POP. ARIMINUM CIRCUS AL BOOK PRIDE 2025
93 – OPINION PIECE DI SIMONE VIGEVANO
94 – OPINION PIECE DI LORENZO FARISELLI
95 – OPINION PIECE DI MARTINA FRANZINI
96 – OPINION PIECE DI EMANUELA RIZZO
97 – INNOVAZIONE POP. OLTRE LA PRE-INTERPRETAZIONE
98 – INNOVAZIONE POP. FORMAZIONE: ANALOGICA, METAVERSALE, IBRIDA
99 – ARIMINUM CIRCUS: LA VISUAL NOVEL!
100 – La (P) AI INTELLIGENCE (PARTE PRIMA)
101 – La (P) AI INTELLIGENCE (PARTE SECONDA)
102 – La (P) AI INTELLIGENCE (PARTE TERZA)
103– La (P) AI INTELLIGENCE (PARTE QUARTA)
104– La (P) AI INTELLIGENCE (PARTE QUINTA)
105– OPINION PIECE DI ALEXANDRA NISTOR
106– FORMAZIONE POP. PARTE PRIMA
107– FORMAZIONE POP. PARTE SECONDA
108– OPINION PIECE DI FEDERICA GRAZIA BARTOLINI
109– OPINION PIECE DI FEDERICO PLATANIA
110– OPINION PIECE DANIELA DI CIACCIO
111– OPINION PIECE DI LUCIANA MALARA E DONATELLA MONGERA
112– IL RITORNO DEL CEOPOP
113– LA VISIONE DEI CEOPOP (VOLUME 1)
114– LA VISIONE DEI CEOPOP (VOLUME 2)
115 – LA COMUNICAZIONE DEL CEOPOP
116– CEOPOP E PARTI SOCIALI
117– CHE POP MANAGER SEI? L’ESTETA
118– STORYTELLING POP. UNA COMUNICAZIONE POP PER IL NON PROFIT
119– CHE POP MANAGER SEI? VISIONARIO/VISIONARIA
120– OPINION PIECE DI REMO PONTI
121– CHE POP MANAGER SEI? EMPATICA/EMPATICO
122– OPINION PIECE DI GIACOMO GRASSI
123– CHE POP MANAGER SEI? INNOVATORE/INNOVATRICE
124– SECONDA CONVERSAZIONE COLLABORATIVA SUL POP BRANDING
125– CHE POP MANAGER SEI? SIMPOSIARCA
126– SENSEMAKING POP. UNA NUOVA GRAMMATICA DEL LAVORO (1)
127– CHE POP MANAGER SEI? ESPLORATORE/ESPLORATRICE
128– SENSEMAKING POP. UNA NUOVA GRAMMATICA DEL LAVORO (2)
129– CHE POP MANAGER SEI? IRONIC DIVA/DIVO
130– SENSEMAKING POP. UNA NUOVA GRAMMATICA DEL LAVORO (3)
131– CHIUSI PER FERIE
132– OPINION PIECE DI ELENA BOBBOLA E MARIE LOUISE DENTI
133– CHE POP MANAGER SEI? PRATICO/PRATICA
134- L’INTELLIGENZA COLLABORATIVA MOTORE POP DEL CHANGE MANAGEMENT – INDUSTRIA
135- L’INTELLIGENZA COLLABORATIVA MOTORE POP DEL CHANGE MANAGEMENT – NO SERVIZI
136- L’INTELLIGENZA COLLABORATIVA MOTORE POP DEL CHANGE MANAGEMENT – NO PROFIT
137- LEADERSHIP POP E VIDEOGIOCHI. PARTE PRIMA
138- LEADERSHIP POP E VIDEOGIOCHI. PARTE SECONDA